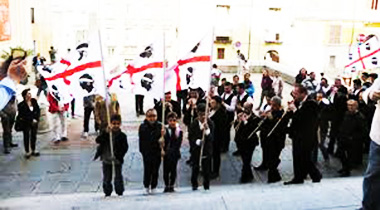Per il 28 aprile, di Luciano Carta
Posted By cubeddu On 26 aprile 2020 @ 06:23 In Blog,Sa die de sa Sardigna,Storia della Sardegna | Comments Disabled
Tutto quello che un cittadino sardo, lo studioso come il patriota, vuole sapere sull’inno nazionale della Sardegna alla vigilia de ‘sa Die de sa Sardigna’ 2020: ‘Procurad’ ‘ e moderare…’.
La direzione e la redazione di questo sito ringraziano l’amico e storico prof. Luciano Carta per il regalo di questo volume – con il titolo di “Per il 28 aprile” – che vede la luce oggi alla vigilia delle celebrazioni della festa del Popolo sardo, sa Die de sa Sardigna 2020.
Esso rappresenta in maniera completa quanto il lettore e lo studioso chiedono di sapere sul canto principale della ‘Sarda Rivoluzione”: Innu de su patriota sardu a sos feudataros, di Francesco Ignazio Mannu. Le sue strofe sono state formalmente indicate dal Consiglio regionale della Sardegna – il presente Parlamento sardo – quale inno nazionale della Sardegna.
Il volume si compone di quattro parti. La prima contiene la lettura drammatizzata del testo ‘Procurad’ ‘e moderare …’, titolo che pure indica l’inno dal primo suo verso. Questo primo capitolo viene riproposto tramite video nella comunicazione scolastica in atto in questi giorni in Sardegna e verrà letto nella sede istituzionale più importante dell’Isola – quella, appunto, del Consiglio – la mattina di martedì 28 aprile.
Nella seconda parte lo storico Carta estende la propria ricerca con l’inquadramento storico della composizione nella temperie di avvenimenti che la giustificano e la esaltano. Nella terza l’Autore ci offre la propria traduzione italiana dell’inno accompagnandolo con il commento delle singole strofe. Nella quarta, infine, si riporta la traduzione in lingua italiana operata dal poeta nuorese Sebastiano Satta nel 1896.
Buona lettura ed auguri per tutto in occasione di SA DIE DE SA SARDIGNA!
(Martedì, 28 aprile, questo sito pubblicherà, dello stesso Autore, il breve saggio dal titolo: Chi era Francesco Ignazio Mannu, l’autore dell’inno del Popolo sardo “Procurade ‘e moderare barones sa tiranìa”?
Per il 28 aprile
Il 28 aprile 2018 il Consiglio Regionale della Sardegna approvava la legge regionale, pubblicata sul BURAS il 4 maggio 2018 n. 14, che sanciva l’adozione dell’inno di Francesco Ignazio Mannu Su patriota sardu a sos feudatarios – universalmente noto dai primi due versi Procurade ’e moderare barones sa tirannia – come Inno ufficiale della Regione Sarda. In seguito, con la legge regionale 24 aprile 2019 e con il Decreto Presidenziale del 7 agosto n. 86 venivano precisate la melodia con cui esso deve essere eseguito nelle cerimonie ufficiali (quella tradizionale dei Gosos) e le strofe da cantare (le nn. 1, 2, 4, 24, 46-.47).
L’inno, nato nel cuore delle vicende dell’ultimo decennio del Settecento sardo, durante il triennio 1793-1796, fin dall’anno della sua composizione è stato, per eccellenza, il canto con cui i Sardi dell’età contemporanea, hanno sempre espresso l’aspirazione ad una società più giusta contro ogni sopruso e contro ogni oppressione, allo stesso modo in cui, con la coeva Marsigliese di Rouget de Lisle, i Francesi hanno espresso la loro aspirazione ad una società di liberi ed uguali.
Su patriota sardu a sos feudatarios è, dunque, il canto con cui il Popolo sardo si è storicamente inserito nelle conquiste del mondo contempraneo e con cui ha manifestato da due secoli a questa parte le sue più profonde aspirazioni ad una società giusta e di uomini liberi. L’inno, costretto “alla macchia” per tutta la prima metà dell’Ottocento, negli anni della Restaurazione e del governo assoluto dei Savoia, è stato “riscoperto” nell’isola dal canonico Govanni Spano nel 3° volume delle sue Canzoni popolari inedite in dialetto sardo centrale ossia logudorese, pubblicato nel 1865, pur connotandolo come «una di quelle solite produzioni di cui sogliono essere fecondi i tempi di anarchia». In modo più equanime, a dimostrazione di quanto quel carme fosse vivo nella cuore e nella memoria, costretta alla clandestinità dai governi assoluti, degli intellettuali progressisti sardi, esso era stato giudicato dal viaggiatore inglese John Warre Tyndale, che lo aveva pubblicato, con traduzione inglese a fronte nel 1849 nella sua ponderosa opera in 3 volumi The Island of Sardinia: «in quella commozione di animi [dei moti antifeudali della fine del Settecento] – egli scriveva – non fuvvi alcun’altra scrittura che abbia scalfito più al vivo la possanza feudale».
A consacrare in modo definitivo l’inno del Mannu come canto di lotta e di protesta contro ogni ingiustizia sociale furono gli intellettuali radicali della fine dell’Ottocento e tra essi, in particolare, Sebastiano Satta, che ne offriva una traduzione in versi in lingua italiana su “La Nuova Sardegna” del 1° marzo 1896, in occasione delle celebrazioni del primo centenario del governo del Capo di Sassari in qualità di Alternos da parte di Giovanni Maria Angioy tra marzo e giugno 1796 e della sua sfortunata “marcia” su Cagliari per ottenere l’abolizione dell’odiato e anacronistico sistema feudale che ancora opprimeva le popolazioni rurali della Sardegna in pieno secolo dei Lumi.
Se è indubbio, dunque, il valore storico e identitario dell’inno, si deve tuttavia lamentare una conoscenza molto approssimativa di esso da parte di una larghissima fascia di popolazione sarda. Circostanza, occorre aggiungere, sicuramente favorita dal fatto che la composizione poetica è assai complessa, constando di ben 47 ottave, per un totale di 376 versi, di non sempre agevole comprensione. Chi scrive ha dedicato ad essa un volume, uscito nel 2002 e in 2a edizione nel 2006, che costituisce a tutt’oggi la più completa edizione storico-critica disponibile tra le opere a stampa. Trattandosi di un lavoro complesso e minuzioso come sono le opere di carattere storico e filologico – la parte filologica è stata curata dal docente di Filologia romanza prof. Paolo Maninchedda – è sembrato opportuno, per facilitare al più vasto pubblico la comprensione dell’inno, in occasione della Festa del Popolo Sardo, curarne una trattazione di carattere divulgativo con il presente opuscolo, che si articola in quattro Sezioni.
1) 1a Sezione – Propone una drammatizzazione del testo poetico in chiave storica, attraverso una “scomposizione” delle 47 strofe che ripercorre, in senso diacronico, le vicende del “Triennio rivoluzionario sardo” chiaramente individuabili al suo interno, dalla guerra vittoriosa contro la tentata invasione francese nell’inverno 1793 alla cacciata dei Piemontesi il 28 aprile 1794 e alla lotta delle popolazioni rurali contro il sistema feudale durante il 1795.
2) 2a Sezione – Viene suggerita, attraverso un agile saggio storico, una chiave di lettura dell’inno del Mannu all’interno della temperie culturale e politica del Settecento sardo, partecipe, con tutti i limiti propri del condizionamento geografico dell’isola, della cultura del secolo dei Lumi.
3) 3a Sezione – Si offre, ai lettori più volenterosi, un commento puntuale di tutto l’inno, in modo da offrire la possibilità di una comprensione integrale di esso.
4) 4a Sezione – Viene riproposta, insieme al testo dell’inno così come era conosciuto prima della fondamentale opera di Raffa Garzia datata 1899, la versione poetica in lingua italiana di Sebastino Satta in occasione, nel corso del 1896, del primo centenario della “marcia” di Giovanni Maria Angioy da Sassari a Cagliari, promossa dalla intellettualità progressista dell’Isola, legata al quotidiano La Nuova Sardegna, che ha consacrato la definitiva “fortuna” di Procurade ’e moderare come canto di lotta e di protesta.
L’auspicio più sentito è, infine, di contribuire, oltre che a una conoscenza più puntuale dell’Inno del Popolo sardo, a “sradicare” finalmente dalla communis opinio, alcuni luoghi comuni, che purtroppo continuano a circolare su di esso in opere a stampa e nei mezzi di comunicazione sociale, che denotano una scarsa attenzione e un’imperdonabile leggerezza da parte di tanti nostrani «traduttori de’ traduttor d’Omero».
Tra questi, ne ricordiamo in particolare due. Molti continuano a citare l’inno come “Su patriottu sardu a sos feudatarios”. Il termine “patriottu” – accreditato, come si dirà nella Sezione quarta di questo opuscolo dal poeta nuorese Sebastiano Satta – è del tutto spurio e non appartiene certo all’armonioso logudorese di Ozieri di Francesco Ignazio Mannu, che di fatto ha intitolato la sua opera: “Su patriota sardu a sos feudatarios”. Altri, inoltre, continuano stancamente a ripetere, contro ogni evidente logica interna e i contenuti sostanziali dell’inno, quanto scrisse erroneamente il pur benemerito canonico Giovanni Spano, che datò l’inno al 1794. In realtà l’inno fu composto nel cuore della lotta delle popolazioni rurali contro il feudalesimo, che ebbe il suo apice nel 1795 e non nel 1794. Fu a partire da quell’anno cruciale della lotta antifeudale, ai cui contenuti e rivendicazioni tutto l’inno si ispira, che, come ha scritto lo storico algherese Giuseppe Manno, esso divenne il canto di quanti rivendicavano il superamento del sistema feudale come indilazionabile premessa per il benessere della società sarda.
Parte prima
una lettura drammatizzata dell’inno di francesco ignazio mannu
“procurade ’e moderare barones sa tiranìa”
Su drama de sa “revolutzione sarda” contadu in 5 Attos: s’innu sardu “Su patriota sardu a sos feudatarios” de Franziscu Innassiu Mannu.
Amigas e amigos istimadas e istimados,
Oe, 28 de abrile, est sa Festa de su populu sardu, sa ’e vintises dae candho sa Regione sarda, in su 1993, at fattu sa legge. Sa Festa ammentat sa die inue sos Sardos ch’ant bogadu sos Piemontesos, “sa di’ de s’acciappa”, comente si narat in campidanesu. Ma sa Festa cheret ammentare puru totu cussos tres annos famàdos, intra su 1793 e su 1796, chi li namos sos annos de sa “Revolutzione sarda”, dae sa gherra vittoriosa contra sos Franzèsos a s’impresa de créschida tzivile de Giommaria Angioy, chi, po malesaùra, no est resurtada binchidora.
Calicunu at a narrer: It’est una “revolutzione” chi non at bìnchidu?
Poite, namos nois, totu sas “revolutziones” sunt istadas binchidoras? Su chi contat est chi sas ideas non morint mai e chi, dae duos seculos, sos Sardos abbàidant a cussos annos, ischidindhe chi sa “Revolutzione sarda” e Giommaria Angioy sunt s’abbrèschida de sa Sardigna de oe. Comente sos Franzesos ant fattu sa Revolutzione issoro, gai sos Sardos, in cussos matessi annos, ant fattu sa Revolutzione de domo issòro. Acò, edduncas, sa nezessidade de torrare a totu cussos pensamentos, cussas sufferentzias, cussas idealidades de sos Sardos de tandho, chi ant abbertu s’edade cuntemporanea, chi semus sighinde a vìvere oe, comente totu sos populos de s’Occidente.
Cussos eventos famados b’at istadu unu poeta, chi, cun musa ispirada, los at cantados in s’innu Su patriota sardu a sos feudatarios, chi dae s’annu passadu est diventadu s’innu offiziale de sa Regione sarda. Cussu poeta est Franziscu Innassiu Mannu, zùighe othieresu, chi at vìvidu de presentzia cussos fattos e in sas 47 ottavas de sa cantone sua at intrepetadu sos sentìdos, sos disìzzos, su programa de una menzus vida de sos Sardos, chi tandho si sunt bortàdos non solu contra sos Piemontesos, ma prus ancora contra sa gangrena de cussos tempos: sos feudatarios e su sistema feudale, chi che cheriant destruìdu.
Acò, duncas, su chi cherìmos faghere oe: presentare custu “innu de su populu sardu”, est a narrer sa cantone Su patriota sardu a sos feudatarios, chi totu connoschìmos dae su primu versu Procurade ’e moderare, lezzindhebèi a intro sos eventos de s’istoria sarda dae su 1793 a su 1795.
Poite 1795 e non 1796, s’annu chi ch’ant iseniàdu a Giommaria Angioy?
Ca in s’innu de su poeta othieresu, su chi at fattu s’Alternos Giommaria Angioy in su Cabu ’e Susu non bi est contàdu; infattis sa cantòne resurtat cumposta in su 1795, candho sos Sardos de sas campagnas de Sardigna, a una ’oghe, ant dimandhadu e pretesu de che destrùere su sistema feudale. Su chi Angioy at fattu in Tattari, appustis chi su populu cabesusèsu ch’at zagaràdu sos feudatarios dae sa tzittade, dae su mese ’e martu a lampadas de su Norantases, no est ateru si non s’isfortzu de ponner in pè’ su chi sos Sardos ant giai reconnottu e iscrittu in sos meses de atunzu de su 1795 in sos Attos de unione e de cuncordia: a fora sos feudatarios! “A fora su despotismu”! A fora sos “tirannos minores”!
Pro bi lezzer intro totu sos eventos dae su 1793 a su 1795, dae s’invasione franzèsa a su 28 ’e nadàle 1795, candho un’esercitu de zente de campagna, omines e feminas de Logudoro, ghiadu dae Franziscu Cilloco e Giauachinu Mùndula, at conchistadu a Tattari, chi fintzas a tandho fit sa fortilesa de sos feudatarios, podìmos iscumpònnere s’innu e ndhe faghimos unu drama in 5 Attos:
1) Attu primmu: cumprendhet sas cambas dae 1 a sa ’e 3 de s’innu, chi est su Proemiu inue su poeta faghet s’isterrida de su tema: s’avvertentzia a sos feudatarios chi su populu non ndhe podet pius de cussa tirannia edd’est creschìndhe su razzòlu de su populu: “sas aèras minettant temporale”!
2) Attu segundu: cumprendhet sas cambas dae sa ’e 28 a sa ’e 30, inue su poeta ammentat in tres ottavas s’istoria de cussos annos, dae s’invasione franzesa a sas Chimbe preguntas fattas dae sos Istamentos a su re e chi custu no aat chérfidu cuntzédere a sa delegatzione de sos deputados sardos in Turinu.
3) Attu terzu: comprendhet sas cambas dae sa ’e 31 a sa ’e 43, chi contat “sa dì’ de s’acciappa”, est a narrer candho sos Sardos ch’ant barriàdu sos Piemontesos, che una mandra de berbeghes, in parizzas naves e che los ant bogados dae s’Isula nostra. E su poeta narat proite totu custu. In pagas paraulas, ammentandhe carchi versu de Mannu, totu custu sos Sardos l’ant fattu po s’arrogantia e sa prepotentzia de sos chi si cumportaiant che meres de Sardigna: “Fit po sos Piemontesos sa Sardigna una cuccagna”; “Nos arziaìat sa ‘oghe finzas unu camareri”, e gai sighindhe; e su matessi fit po sos feudatarios, alleàdos de sos Piemontesos.
4) Attu quartu: cumprendhet sas cambas dae sa ‘e 4 a sa ’27 e podìmos narrer che est su coro veru de s’innu de Franziscu Innassiu Mannu, inue mustrat tota s’iniquidade de su sistema feudale e sa netzessidade chi tenent sos Sardos de che la cherrer destrùere.
5) Attu quintu: cumprendhet sas cambas dae sa ’e 45 a sa ’e 47, inue, a fine de s’innu, su poeta attitat su populu a che bogare un ‘orta po sempre su despotismu de sos feudatarios e s’anacronismu de su sistema feudale dae su corpus martoriadu de sa Sardigna: “Custa populos est s’ora d’estirpare sos abusos … gherra gherra a s’egoismu e contra su despotismu”!
Attu I
Cambas dae sa ’e 1 a sa ’e 3.
E tandho, comintzamos cun su primmu Attu de custu drama de sa Sardigna de su Settighentos. Est un’AVVERTENTZIA, a sos barones, a abbassare corra, ca sutta sa brasia e sa chisìna s’est pesandhe su fogu e “sas aèras minèttana temporale”; “su poveru runzinu” de sas prepotenzias issoro, “no ndhe podet piùsu” e candho s’arrennègu est birandhe, tandho cussu Populu de animales “lanzos e cansados” bos ndhe ’ettat dae sa seddha e bos torrat “a pè’ in terra”.
Che a babbos nostros, cantamonnòlla cust’avvertentzia e custa minetta.
[Su Coro cantat sas primmas duas cambas; sa ’e tres la narat sa 1a ’oghe].
Coro
1.
Procurade ’e moderare
Barones sa tiranìa,
Chi si no per vida mia
Torrades a pè in terra.
Declarada est già sa gherra
Contra de sa prepotenzia
E cominzat sa passienzia
In su populu a faltare.
2.
Mirade ch’est azzendende
Contra de bois su fogu,
Mirade chi no est giogu,
Chi sa cosa andat de veras,
Mirade chi sas aèras
Minettana temporale;
Zente consizada male,
Iscultade sa oghe mia.
1a ’oghe
3.
No appretedes s’isprone
A su poveru runzinu,
Sinò in mesu caminu
S’arrempellat de appuradu,
Minzi ch’est lanzu, e cansadu
E no nde podet piusu
Finalmente a fundu in susu
S’imbastu nde hat a bettare.
Attu II
Cambas dae sa ’e 28 a sa ’e 30.
Sighindhe su filu suo, su poeta in s’innu cantata totu sos males de su sistema feudale in sas cambas dae sa ’e 4 a sa ’e 27.
Nois però cherìmos sighìre in ordine de tempus sos eventos de sos tres annos da sa “Revolutzione sarda”, chi cominzant dae s’invasione franzesa in zennarzu e fearzu de su 1793, e sighit cun sa reunione de su Parlamentu sardu in su mese de Abrile, sas Chimbe preguntas a su re de reforma, sa risposta negativa. In s’innu custos eventos sunt contados in tres cambas, dae sa ’e 27 a sa ’e 30.
Sos riformadores, sos “patrizios pius zelantes”, sunt cussos chi ant cumbàttidu po difendher sa patria in su zerru de su ’93 – “s’ispada ant bogadu po sa causa comune” -; chi ant affirmadu sos derettos de sos Sardos in su Parlamentu reunìdu in su ’eranu de su ’93 – “in favore de sa patria ant peroradu”-; custos chi sunt sos patriotas veros, sos feudatarios e sos Piemontesos los cheriant mortos e los cheriant “massacrare comente a Giacobinos”.
Mirade, bois chi iscurtades: semus in su 1795. B’at chie diat cherrer presentare una Sardigna chi pagu ischit de su chi sutzedit in Francia e in s’Europa. Nono, mirade, no est gai. In custos versos su poeta mustrat d’esser bene informadu de su chi est capitadu in Francia: su Terrore de Robespierre, su Comitadu de Salude Prubbica intra su mese de triulas de su 1793 e su mese de triulas ’94, su Corpu de Istadu de su 9 de Termidoro (27 de triulas de su 1794), e appustis su “massacru de sos Giacobinos” in su mese de sant’andria de su matess’annu.
Però sos “veros patriotas” e su poeta Giacobinos non sunt e non s’intendhent. Sunt e cherent essere reformadores non Giacobinos. Solu po esser reformadores sos guvernantes e sos feudatarios los cherent massacrare, ca issos faghent donzi manizzu e ingannu po che fagher passare sos reformadores pro giacobinos.
Ma iscurtamos su poeta e in sa ’e 30 cambas cunsideramos sa fide sinzera chi tenet in Deus, ca isse tenet cussentzia chi sos chi faghent sa gherra contra “sos malos usos” cumbattint pro una causa zusta e santa.
1a ’oghe
28.
Timende chi si reformen
Disordines tantu mannos,
Cun manizos, et ingannos
Sas Cortes han impedidu;
E isperder han querfidu
Sos Patricios pius zelantes
Nende chi sun petulantes
E contra sa Monarchia.
2a ’oghe
29.
Ai cuddos ch’in favore
De sa patria han peroradu
Chi s’ispada hana bogadu
Pro sa causa comune
O a su tuyu sa fune
Cherian ponner meschinos
O comente Giacobinos
Los cherian massacrare.
3a ’oghe [si est possibile una femina]
30.
Però su Chelu hat deffesu
Sos bonos visibilmente,
Aterradu hat su potente,
Ei s’umile exaltadu;
Deus chi s’est declaradu
Pro custa Patria nostra,
De ogni insidia bostra
Isse nos hat a salvare.
Attu III
Cambas dae sa ’e 31 a sa ’e 44.
Passamos como, sighindhe sos tempos e sos annos da sa “Revolutzione sarda”, a su chi capitat in Sardigna candho, in su mese de abrile de su 1794, su Re Vittoriu Amedeu III non dat risposta positiva a sas Chimbe preguntas de su Parlamentu sardu.
Su populu de Casteddhu si pesat contra su Guvernu su 28 de abrile 1794 e pagas dies appustis, a sos primmos de maggiu, che cazzat dae su Regnu totu sos Piemontesos.
In 14 cambas su poeta cantat s’istoria de sa dominatzione de sos Piemontesos, comintzada in su 1720, chi su populu ch’hat deppidu zagarare dae Sardigna.
Proite che los ant zagarados?
Ca issos sunt sos alleados de sos barones; issos ant sempre cunsideradu sa Sardigna che “una cuccagna”; issos ant “arruinadu” e fattu pobera s’isula nostra; issos tenent sos impreos prubicos e lassant “oziosa” sa “numerosa gioventude” sarda, chirrandhe a bortas po sos impiegos “sos pius tontos”; issos ch’ant carradu a su Piemonte “sa prata nostra, e i s’oro”.
In su mese de maggiu de su 1794, “custa razza de bastardos chi s’isula ant arruinadu” sos Sardos che los ant catzados, ma su “perfidu feudatariu” sighit a lis essere amigu, ndhe los cheret torrare e in su mentres sighit a bagassare in Turinu, prostituindhe s’Isula nostra e basandhe su culu a sos Piemontesos. Poberos maccos, chi in Turinu che lassant “sa buxia”, in cambiu mancari “de una rughitta in pettorras”.
Ma Deus non lassat semper “sa malissia triunfendhe”; po more de zustissia Deus puru che cheret destruìdos sos Piemontesos e sos alleados insoro, sos feudatarios. Cun s’azzudu de Deus su populu sardu ischit chi “su sistema feudale non podet durare meda”.
Iscurtamos como su poeta e totu su chi narat contra sos Piemontesos e contra sos feudatarios.
Sas cambas est menzus chi las narent totas sas tres boghes, duas de omine e una de femine, segundhu cust’ordine:
- Boghe de omine: cambas 31 – 33.
- Boghe de femina: cambas 34 – 36.
- Boghe de omine: cambas 37-38.
- Boghe de omine: camba 39 [in tonalidade forte]
- Boghe de femina: cambas 40-41.
- Boghe de omine: cambas 42-43.
- Camba 44: la cantat su Coro.
1a ’oghe [cambas 31-33 – omine]
31.
Perfidu Feudatariu!
Pro interesse privadu,
protettore declaradu
ses de su Piemontesu:
cun isse ti fisti intesu
cun meda facilidade,
isse papàda in Citade,
e tue in Bidda a porfia.
32.
Fit pro sos Piemontesos
Sa Sardigna una cucagna
Su chi in sas Indias s’Ispagna
Issos incontràn inoghe:
Nos alzaiat sa boghe
Finza unu Camereri,
O plebeu, o Cavaglieri
Si deviat umiliare.
33.
Issos dae custa terra
Ch’hana bogadu migliones
Benian senza calzones
E sinde andàn galonados;
Mai ch’eseren intrados
Chi hana postu su fogu;
Malaitu cuddu logu,
Chi criat tale zenia.
2a ’oghe [cambas 34-36 – femina]
34.
Issos inoghe incontràna
Vantaggiosos hymeneos
Pro issos fin sos impleos,
Pro issos fin sos honores,
Sas dignidades mazores
De Cheia, Toga, e Ispada
E a su Sardu restàda
Una fune a s’impicare.
35.
Sos disculos nos mandàna
Pro castigu e corressione,
Cun paga e cun penzione
Cun impleu e cun patente;
In Moscovia tale Zente
Si mandat a sa Siberia
Pro chi morgiat de miseria,
Pero no pro governare.
.
36.
Intantu in s’Isula nostra
Numerosa Gioventude
De talentu, e de virtude
Ozïosa la lassàna;
E s’algunu nd’impleàna
Chircàna su pïus tontu
Proghi lis torràda a contu
Cun Zente zega tratare.
3a ’oghe [cambas 37-38 – omine]
37.
Si in impleos subalternos
Algunu Sardu avanzàda,
In regalos no bastàda
Su mesu de su salariu:
Mandare fit necessariu
Caddos de casta a Turinu
E bonas cascias de binu
Cannonau, e malvasia.
38.
Tirare a su Pïemonte
Sa plata nostra, ei s’oro
Est de su Governu insoro
Maxima fundamentale;
Su Regnu andet bene o male
No lis importat niente,
Antis cren incunveniente
Lassarelu prosperare.
1a ’oghe [cambas 39 – omine – tonalidade forte]
39.
S’Isula hat arruinadu
Custa razza de bastardos
Sos privilegios Sardos
Issos nos hana leadu;
De sos Archivos furadu
Nos hana sas mezzus pezzas
E che iscrituras bezzas
Las hana fattas bruxiare.
2a ’oghe [cambas 40-41 – femina]
40.
Dae custu flagellu in parte
Deus nos hat liberadu
Sos Sardos ch’hana bogadu
Custu dannosu inimigu;
E tue li ses amigu
O Sardu Barone indignu?
E tue ses in s’impignu
De ndelu fagher torrare?
41.
Pro custu iscaradamente
Preïgas pro Pïemonte:
Falsu chi portas in fronte
Sa marca de traitore;
Fizas tuas tantu onore
Faghen a su Furisteri,
Mancari siat Basseri
Bastat chi Sardu no siat.
3a ’oghe [cambas 42-43 – omine]
42.
S’a casu andas in Turinu,
Inie basare des
A su Ministru sos pes,
E a atter, “su […] già m’intendes”
Pro ottenner su chi pretendes
Bendes sa patria tua,
E procuras forzi a cua
Sos Sardos iscreditare.
43.
Sa buxia lassas inie
Ed in premiu nde torras
Una rughita in pittorras
Una giae in su traseri;
Pro fagher su quarteri
Sa domo has arruinadu
E titulu has acquistadu
De traitore e ispia.
Coro
44.
Su Chelu non lassat sempre
Sa malissia triunfende,
Su Mundu istat reformende
Sas cosas chi àndana male,
Su sistema Feudale
No podet durare meda:
Custu bender pro moneda
Sos Populos det cessare.
Attu IV
Cambas dae sa ’e 4 a sa ’e 27.
E como, in su ’e battoro attos de su drama nostru, appustis de aer ammentadu su passadu, che semus in su coro de s’argomentu. Dae sa ’e battor cambas a sa ’e vintisette su poeta descriet in longu e in largu, comente podet faghere s’avvocadu de “sos poberos de sas biddas”, totu sos males de su sistema feudale e sas malissias de sos feudatorios, cussos “tirannos minores” chi suzzant su sambene de sos poberos.
Mirade, inoghe s’avvocadu abberit s’argumentu porrindhe primma ’e totu s’attore printzipale de custu drama: su Populu, su Populu sardu, chi suffrit, isperat e, candho bi cheret, faghet sa “gherra a sos oppressores”. Appustis cominzat su contu, chi camba po camba, est denuntzia, est lamentu, est invocatzione de zustissia e de una sotziedade pius zusta e chi siat digna de la vivere in su tempus benidore.
In sas cambas dae 5 a 7 si poeta ammentat s’attu violentu chi at impostu su sistema feudale: pagos potentes s’ant dividìdu terras, biddas, populassiones, “comente unu cumone de bestias berveghinas”. Neunu lis podiat dare custa facultade chi est contra onzi derettu de natura; edduncas cussos feudatarios ant furadu e su male acchistadu lu deppent torrare, si non cun sas bonas, cun sas malas maneras, ca su Populu si ndh’est ischidadu dae su letargu seculare e “sa presente edade” est dezisa a “remediare” a totu sos males de sa sotziedade.
Dae sa camba 8 a sa ’e 14 s’avvocadu/poeta descriet totu sos males de su feudalismu: “su Sardu suggettu a milli cumandhamentos”, a milli tassas, “tassas pro sa pastura e tassas pro laorare”; su dinari impreadu dae sa nobiltade in festas e in milli divertimentos, non po guvernare sa sotziedade. Si sas cosas sunt gai, tandho totu cussos “dinaris furados” a sos poberos, chi non benint impreàdos po s’iscopu suo, chi est sa prosperidade e su bene de sa zente, su feudatariu bi los deppet torrare. E sa ’e battordighi cambas est unu bellu e profundhu pensamentu de su chi deppet esser “s’unicu fine” de sa sotziedade tzivile.
In sas cambas dae 15 a 18 su poeta contat de sa burocrazia feudale, chirràda non po su meritu ma po s’arbitriu de sos meres, e po cussu etotu governat cun arbitriu e parzialidade, mai cun zustissia.
Sa ’e 19 cambas est unu modu totu populare de narrer chi sa soziedade naschet dae unu “pattu sotziale” e candho unu de sos duos chi at zuradu su pattu lu traìghet, tandho s’ateru est isortu dae onzi obbligassione: “a nuddha [est pius] obbligadu”.
In sas cambas dae sa ’20 a sa ’e 27, imitandhe su poeta lumbardu Zuseppe Parini, Franziscu Innassiu Mannu descriet sa zoronada de sa nobiltade isfazzendhada, de sas damas chi timent de caminare in s’impedradu, de su segnor feudatariu chi si pesat a sas undighe ’e manzanu e andhat derettu “dae su lettu a sa mesa, dae sa mesa a su giogu” e umpare, cun cuntrastu forte, mustrat sa zoronada de su poberu vassallu, chi “si pesat innantis de s’aurora” e “peleat tota die cun su zappu e cun s’aradu”. Unu cuntrastu chi cramat a boghe arta e forte vinditta, zustissia, gherra a sa prepotentzia.
E como iscurtamos su poeta, comintzandhe cun su cantu de su Coro.
- Camba 4: la cantat su Coro.
- Boghe de omine: cambas 5-7.
- Boghe de femina: cambas 8-10.
- Boghe de omine: cambas 11-13.
- Boghe de omine: cambas 14-16.
- Boghe de omine: cambas 17-19.
- Boghe de femina: cambas 20-22.
- Boghe de omine: camba 23 [cun tonalidade forte].
- Camba 24: la cantat su Coro.
- 10. Boghe de femina: cambas 25-27.
Coro
4.
Su Populu, ch’in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente despertadu
S’abbizat ch’est in cadena,
Ch’istat sufrende sa pena
De s’indolenzia antiga,
Feudu, legge inimiga
A bona Filosofia!
1a ’oghe [cambas 5-7 – omine]
5.
Che chi esseret una binza,
Una tanca, unu cunzadu,
Sas Biddas hana donadu
De regalu, o a bendissione;
Comente unu cumone
De bestias berveghinas
Sos homines, e feminas,
Han bendidu cun sa cria.
6.
Pro pagas mizas de liras,
E tale orta pro niente
Isclavas eternamente
Tantas Populassiones
E migliares de persones
Servin a unu Tiranu.
Poveru generu humanu!
Povera Sarda Zenìa!
7.
Deghe o doighi Familias
Si han partidu sa Sardigna,
De una manera indigna
Sinde sun fattas pobiddas,
Divididu si han sas Biddas
In sa zega antiguedade,
Pero sa presente edade
Lu pensat remediare.
2a ’oghe [cambas 8-10 – femina]
8.
Nasquet su Sardu suggettu
A milli cumandamentos,
Tributos, e pagamentos
Chi faghet a su Segnore
In bestiamen e laore,
In dinari e in natura,
E pagat pro sa pastura,
E pagat pro laorare.
9.
Meda innanti de sos feudos
Existiana sas Biddas,
E issas fini pobiddas
De saltos e bidatones
Comente a bois Barones
Sa cosa anzena passàda?
Cuddu chi bos l’hat donada
No bos la podiat dare.
10.
No est cosa presumibile
Chi voluntariamente
Appat sa povera zente
Cedidu a tale derettu;
Su titulu ergo est infettu
De s’infeudassione,
Ei sas Biddas rexone
Tenene de l’impugnare.
3a ’oghe [cambas 11-13 – omine]
11.
Sas tassas su principiu
Exigiazis limitadas,
Dae pustis sun andadas
Ogni die aumentende
A mesura chi creschende
Sezis andados in fastu
A misura ch’in su gastu
Lassezis s’economia.
12.
Nè bos balet allegare
S’antiga possessione;
Cun minetas de presone,
Cun gastigos, e cun penas
Cun cippos, e cun cadenas
Sos poveros ignorantes
Deretos exorbitantes
Hazis forzadu a pagare.
13.
A su mancu s’impleeren
In mantener sa Giustissia
Castighende sa malissia
De sos malos de su Logu;
A su mancu disaogu
Sos bonos poteren tenner
Poteren andare e benner
Seguros peri sa via.
1a ’oghe [cambas 14-16 – omine]
14.
Est custu s’unicu fine
De ogni tassa e deretu,
Chi seguru, e chi quietu
Sutta sa legge si vivat;
De custu fine nos privat
Su Barone pro avarissia,
In sos gastos de Giustissia
Faghet solu economia.
15.
Su primu chi si presentat
Si nominat Offissiale
Fattat bene, o fattat male
Mentras no chirchet salariu
Procuradore, o Notariu,
o Camereri, o Lacaju,
siat murru, o siat baju,
est bonu pro guvernare.
16.
Bastat chi prestet sa manu
Pro fagher crescher sa renta,
Bastat chi fattat cuntenta
Sa buxia de su Segnore
Chi aggiudet a su fattore
A crobare prontamente,
E si algunu est renitente,
Chi l’iscat executare.
3a ’oghe [cambas 17-19 – omine]
17.
A bortas de Podatariu
Guvernat su Capellanu
Sas Biddas cun una manu;
cun s’altera sa dispenza;
Feudataïriu pensa
Chi sos vasallos non tenes,
solu pro crescher sos benes
solu pro los iscorzare.
18.
Su patrimoniu, sa vida
Pro defender su villanu
Cun sas armas in sa manu
Cheret ch’istet notte, e die:
Già ch’hat a esser gasìe
Proite tantu tributu?
Si no sinde hat haer frutu
Est locura su pagare.
19.
Si su Barone no faghet
S’obligacione sua,
Vassallu, de parte tua
A nudda ses obligadu
Sos deretos chi hat crobadu
In tantos annos pasados
Sunu dinaris furados
E ti los devet torrare.
2a ’oghe [cambas 20-22 – femina]
20.
Sas rentas servini solu
Po mantenner cicisbeas,
Pro carozzas, e livreas
Pro inutiles servicios,
Pro alimentare vicios,
Pro giogare à sa bassetta,
E pro poder sa braghetta
Fora de domo isfogare:
21.
Pro poder tenner piatos
Bindighi e vinti in sa mesa
Pro chi potat sa Marchesa
Sempre andare in portantina
S’iscarpa istrinta mischina,
La faghet andare a topu
Sas pedras punghene tropu,
E no podet caminare.
22.
Pro una littera sola
Su Vassallu poverinu
Faghet dies de caminu
A pè, e senza esser pagadu;
Mesu iscurzu, e ispozadu
Espostu a dogni inclemenzia
Eppuru tenet passienzia,
Eppuru devet cagliare.
1a ’oghe [camba 23- omine – cun tonalidade forte]
23.
Ecco comente s’impleat
De su poveru su suore
Comente eternu Segnore
Sufrides tale ingiustissia!
Bois divina giustissia
Remediade a tales cosas;
Bois de sas ispinas rosas
Solu podides bogare.
Coro
24.
O poveros de sas Biddas
Trabagliade trabagliade
Pro mantenner in Cittade
Tantos caddos de istalla,
A bois lassan sa palla,
Issos ragoglin su ranu,
E pensan sero e manzanu
Solamente a ingrassare.
2a ’oghe [cambas 25-27 – femina]
25.
Su Segnor Feudatariu
A sas undighi si pesa
Dae su lettu a sa mesa,
Dae sa mesa a su giogu,
E pustis pro disaogu
Andat à cicisbeare,
Crompende a iscurigare
Teatru, ballu, allegria.
26.
Cantu diferentemente
Su Vassallu passat s’ora!
Innanti de s’aurora
Già est bessidu in campagna,
Bentu, e nie in sa montagna
In su paris sole ardente;
O poveritu comente
Lu podet agguantare?
27.
Cun su zappu e cun s’aradu
Peleat tota sa die,
A ora de mesu die
Si cibat de solu pane;
Mezus paschidu est su cane
De su Barone in Cittade
Si est de cudda calidade
Ch’in falda solen portare.
Attu V
Cambas dae sa ’e 45 a sa ’e 47.
E semus arrivados a s’urtimu Attu cun sas cambas dae sa ’e 45 a sa ’e 47. Appustis de s’istrofa 45, chi servit comente suntu de sos disizzos de sos vassallos e de pregunta forte e netta de s’umanidade tota, chi dimandhant dignidade e rispettu, cun s’invitu a sighire “sa ghia” indittada dae s’istoria, dae sa moralidade, dae sa zustissia, sas cambas 46-47 intzìtant in manera forte e liera, a sa gherra contra onzi inzustissia e contra onzi prepotentzia. Custas duas cambas las cantamos totucantos a una ’oghe sola.
Camba 45: Boghe de omine [cun tonalidade forte].la narat sa prima ‘oghe.
Cambas 46-47: las cantant totucantos.
1a ’oghe [camba 45 – omine]
45.
S’homine chi s’impostura
Haiat già degradadu
Paret ch’a s’antigu gradu
Alzare cherfat de nou,
Paret chi su rangu sou,
Pretendat s’Humanidade.
Sardos mios ischidade,
E sighide custa ghia.
Totucantos: Coro, boghes e populu.
46.
Custa Populos est s’ora
De estirpare sos abusos
A terra sos malos usos,
A terra su despotismu
Gherra gherra a su egoismu,
E gherra a sos oppressores
Custos tiranos minores
Est precisu umiliare.
47.
Sino calqui die a mossu
Bonde segades su didu,
Como chi est su filu ordidu
A bois toccat su tesser,
Mizzi chi poi det esser
Tardu s’arrepentimentu
Cando si tenet su bentu
Est precisu bentulare.
Parte Seconda
Per un inquadramento storico dell’inno “Procurade ’e moderare barones sa tiranìa”
L’inno di Francesco Ignazio Mannu «Procurade ‘e moderare / Barones sa tiranìa»:
inquadramento storico e ipotesi di datazione.
- Le composizioni poetiche di argomento patriottico e civile in Sardegna tra Settecento e Ottocento
Nel 1864 usciva per i tipi dell’editore Dentu di Parigi l’opera di Auguste Boullier L’ île de Sardaigne. Dialecte et chants populaires. Questo «touriste francese innamorato dell’isola nostra, di cui studiò i canti con grande simpatia e con fine sentimento d’arte», come scrive Raffa Garzia, che agli inizi del secolo avrebbe tradotto l’opera in italiano, osservava che la produzione poetica in lingua sarda è eminentemente lirica e che mancano in essa quasi del tutto le composizioni di argomento patriottico e civile.
Di tale singolare scarsezza il Boullier abbozzava una spiegazione:
Freddo davanti alla bellezza della natura, il poeta sardo si ripiega su se stesso e cant il presente. Il passato non ha per lui nessun ricordo, nessuna ispirazione. E come? La nutrice non parla mai di cose patrie. I monumenti, fatto poi grande, non parlano alla sua mente, tutti intorno a lui ignorano la storia passata e ciascuna età porta con sé i suoi ricordi, le sue passioni. È questa appunto la ragione del perché mancano i canti storici della Sardegna. Certo qualche canto deve aver suscitato nell’animo dei sardi le vicende della loro nazione, ma questi canti non trovando fondamento nell’indole del popolo sparirono con le cause che li produssero: quindi la poesia popolare sarda ha poco d’antico; ciascun secolo che sorge ha nuovi poeti che soppiantano i vecchi e le poesie di questi muoiono troppo spesso con loro. I canti sardi sono essenzialmente lirico-soggettivi.
L’affermazione del Boullier diede luogo ad una lunga querelle, iniziata sulle pagine del “Corriere di Sardegna” con la recensione, nel 1866, di Pietro Amat di San Filippo alla seconda edizione del libro uscita l’anno prima. Lo Amat riteneva che il Boullier, turista frettoloso, non avesse fatto adeguate ricerche e riteneva impossibile che un popolo, così attaccato alle sue tradizioni, difettasse di un genere letterario così importante e consueto. Di questo lontano dibattito, cui presero parte in tempi diversi oltre allo Amat, Giovanni Spano, Giuseppe Pitrè e Raffa Garzia, offre un’accurata disamina Alberto Mario Cirese nel saggio Poesia sarda e poesia popolare nella storia degli studi (“Studi Sardi”, XVII (1959-61), p. 526 segg.).
Il trentennio successivo, anche in coincidenza con l’affermazione del verismo nella letteratura europea, fu fervido di ricerche e di studi sulla cultura e le tradizioni popolari sarde, ma la stessa tradizione orale, accuratamente studiata e pazientemente raccolta, rivelò labili tracce di poesia patriottica: un Canto dei sardi per la guerra d’indipendenza (1848), due composizioni rispettivamente di Michele Carboni di Gavoi e di una poetessa di Ploaghe dedicate alla resistenza dei sardi contro l’invasione dei francesi del 1793, l’inno Su patriota sardu a sos feudatarios di Francesco Ignazio Mannu.
Il touriste francese aveva dunque ragione e ora come allora, a distanza di oltre un secolo, siamo costretti a fare la stessa constatazione. Né l’epopea della Brigata Sassari durante la prima guerra mondiale, né la forte mobilitazione popolare di rivendicazione autonomistica e di lotta per la riforma agraria del primo e del secondo dopoguerra, momenti alti di coralità politica e di passione civile del popolo sardo, hanno offerto motivo d’ispirazione ad una poesia patriottica degna d’attenzione e che abbia, soprattutto, trovato un radicamento nell’immaginario collettivo.
Dalla fine del XVIII secolo ad oggi ad un solo componimento i sardi hanno riconosciuto dignità di canto patriottico, attraverso il quale esprimere il sentimento di ribellione contro le ingiustizie e l’aspirazione ad una società più giusta: l’inno Su patriota sardu a sos feudatarios.
Non può non colpire, da quanto si è accennato sopra, una circostanza. Tre dei canti patriottici che le ricerche demologiche della seconda metà del secolo scorso portarono alla luce, si riferiscono a un momento particolare della nostra storia regionale: la tentata invasione francese del 1793 e la cosiddetta «sarda rivoluzione» che ne seguì. A guardare con attenzione le vicende storiche della Sardegna degli ultimi secoli, gli anni tra il 1793 e il 1796 furono anni drammatici ed eroici in cui il popolo sardo riuscì ad esprimere in modo corale le sue rivendicazioni di autonomia politica e di riforma sociale. L’irripetibile momento di unità patriottica con la rivendicazione delle «Cinque domande» nel 1793-94, la cacciata dei piemontesi il 28 aprile 1794 e la breve intensa stagione di governo autonomo nell’estate di quell’anno, il feroce assassinio del Pitzolo e del Planargia nell’estate 1795, conseguenza del contrasto insanabile tra il partito reazionario e il partito progressista delineatosi in seno al movimento patriottico, l’epopea di Giommaria Angioy della sollevazione antifeudale nel 1795-96, sono i momenti in cui si coagulano ed esplodono i fermenti di un vasto moto popolare che costituisce uno snodo della storia isolana, in coincidenza con i mutamenti epocali dell’Europa intera seguiti all’Ottantanove. Di tutto quel mondo di sentimenti, di passioni, di dibattiti, di disperazione e di speranze, l’espressione più sincera ed emozionante è un inno, nato dal cuore stesso degli avvenimenti: l’inno Su patriota sardu a sos feudatarios di Francesco Ignazio Mannu. È per questi motivi che quest’inno, in modo forse troppo retorico, ma con sufficiente verosimiglianza, è stato definito «la Marsigliese sarda».
- Francesco Ingnazio Mannu: dalla «sarda rivoluzione» alla carriera di magistrato
L’autore dell’inno è Francesco Ignazio Mannu, un personaggio che ha avuto un ruolo importante nell’ambito del «triennio rivoluzionario sardo» del 1793-1796. Della sua biografia ricorderemo qui alcuni momenti essenziali, cercando di collegarli al quadro generale della cultura della Sardegna del secondo Settecento nel quale Mannu si è formato; tale quadro costituisce l’antecedente imprescindibile per una comprensione dell’inno antifeudale.
F. I. Mannu nacque a Ozieri nel 1758 da una famiglia della piccola nobiltà locale; studiò Leggi all’Università di Sassari e dopo la laurea si trasferì a Cagliari dove visse fino al 1839, anno della morte. Dopo aver esercitato l’attività forense, in coincidenza con le sessioni degli stamenti (l’assemblea cetuale caratteristica dell’ordinamento costituzionale del Regno di Sardegna dell’Ancien Régime) autoconvocatisi in occasione dell’invasione francese del gennaio 1793, svolse un’intensa attività politica nello stamento militare di cui era membro e dal luglio 1793 al luglio 1794 funse da avvocato dello stamento stesso, in pratica estensore delle deliberazioni e dei documenti politici di quell’assemblea cetuale caratteristica dell’ordinamento costituzionale del Regno di Sardegna dell’Ancien Régime. Nel 1795 fu nominato giudice ad interim nella sala civile della Reale Udienza, incarico che ricoprì poi ufficialmente a partire dal 1807. Nel 1816 venne spostato ad altro incarico per essersi opposto alle direttive di Carlo Felice, allora viceré, che sollecitava un’amministrazione della giustizia poco rispettosa dei diritti del reo, e dal 1818 fu assegnato al Magistrato del Consolato, tribunale incaricato di dirimere le controversie sul commercio. Parsimonioso e filantropo, alla sua morte lasciò un ingente patrimonio di 40.000 scudi all’ospedale di Cagliari.
Non deve colpire il fatto che l’autore dell’inno antifeudale abbia poi ricoperto altissime cariche burocratiche nella pubblica amministrazione del Regno: la gran parte dei promotori della «sarda rivoluzione» – e Mannu fu tra questi – erano in fondo dei moderati, e l’inno antifeudale è espressione di una visione politica moderatamente riformista, che non mette in discussione la forma politica dello Stato monarchico, il fondamento contrattualistico di questa forma di governo, l’organizzazione cetuale della società; vuole semplicemente che venga asportato dall’organismo politico e sociale della Sardegna un sistema di governo perverso e degenerato, irrispettoso della legge di natura, qual è appunto il sistema feudale. Gran parte dei personaggi che furono ispiratori e promotori della «sarda rivoluzione» occuperanno negli anni successivi le più alte cariche del Regno: ricordo, per essere l’esempio più noto e più emblematico, Vincenzo Cabras – l’anziano avvocato nativo di Tonara il cui arresto con procedura ‘economica’ il 28 aprile 1794 scatenò l’insurrezione antipiemontese a Cagliari – che subito dopo la fine dei moti antifeudali del giugno 1796 diventerà intendente generale, ossia responsabile dell’amministrazione delle finanze. Recenti acquisizioni documentarie consentono di definire in termini abbastanza precisi il ruolo politico svolto da F. I. Mannu nel quadro delle vicende del triennio rivoluzionario sardo; tali nuove acquisizioni offrono pertanto un contributo prezioso per comprendere la genesi e il significato dell’inno antifeudale, che è stato caricato di valenze che non gli appartengono affatto e ne distorcono il significato genuino. Tale è ad esempio la tesi di chi, come Raffa Garzia, ha creduto di individuare l’intima ragione del componimento poetico in un improbabilissimo e storicamente insostenibile «ideale repubblicano di riscossa» del popolo sardo. Nonostante questa forzatura interpretativa, il saggio di Raffa Garzia, Il canto di una rivoluzione, apparso nel 1899, rimane ancora oggi il lavoro più accurato e più denso che si conosca sull’inno.
Non risponde a verità, dunque, com’è stato scritto anche recentemente, che il ruolo del Mannu negli anni della rivoluzione sarda rimane ancora oscuro; al contrario egli ha svolto un’azione energica e propositiva in seno agli stamenti, in difesa dell’autonomia del Regno sardo e della pari dignità di esso nell’ambito dello Stato sabaudo. In qualità di avvocato dello stamento militare tra il luglio 1793 e il luglio 1794 egli è stato l’estensore dei documenti politici di quell’assemblea parlamentare della nazione sarda, documenti nei quali ritroviamo i temi che saranno propri dell’inno antifeudale: la contestazione del centralismo bieco e retrivo del governo di Torino, la rivendicazione di un ruolo attivo dei sardi nel governo dello Stato, la polemica feroce contro la sistematica occupazione dello Stato da parte dei piemontesi fino ad affermare pubblicamente che «avrebbe rinunziato al paradiso qualora vi trovasse un piemontese». Ma l’anti-piemontesismo del Mannu, va precisato, non è frutto di un odio razziale o etnico, ma si tratta di un odio di carattere eminentemente politico.
D’altra parte l’odio di tipo etnico non aveva ragione di essere, soprattutto se si guarda alla formazione culturale del Mannu e più in generale dell’intellettualità isolana del secondo Settecento: dai piemontesi egli e i suoi coetanei avevano ricevuto quella formazione e quell’apertura di idee che costituisce, com’è stato giustamente osservato, l’incubazione della rivoluzione sarda di fine secolo. Francesco Ignazio Mannu appartiene infatti a quella generazione di intellettuali, tra cui sono da annoverare Giommaria Angioy (n. 1751), Domenico Alberto Azuni (n. 1749), Gerolamo Pitzolo (1748), i fratelli Domenico, Matteo Luigi e Gianfrancesco Simon di Alghero (nati rispettivamente nel 1758, nel 1761 e nel 1762), Ignazio Musso (n. 1756), Nicolò Guiso, Efisio Luigi Pintor (n. 1765) – tutti protagonisti, se si eccettua l’Azuni, della rivoluzione sarda – formatisi nelle Università sarde riformate dal ministro Bogino nel 1764-65, forniti di una cultura umanistica e politico-giuridica solida e, soprattutto, partecipe delle problematiche e delle aspirazioni proprie dell’intellettualità europea del secolo dei lumi. Nelle due Università riformate questa generazione di intellettuali era stata allieva di valenti insegnanti come Giambattista Vasco, Francesco Cetti e Francesco Gemelli, che avevano profuso nell’insegnamento universitario sardo una ventata di cultura rinnovata, improntata allo spirito del secolo, l’esprit systématique, per riprendere l’espressione di Condillac, ossia il metodo sperimentale che predilige l’osservazione diretta della natura, della realtà sociale, dei fenomeni economici. Così Giambattista Vasco, uno tra i più rappresentativi illuministi italiani, docente di Teologia dogmatica nell’Università di Cagliari negli anni 1764-67, nelle sue lezioni utilizzava alcune voci dell’Encyclopédie, come ha documentato Franco Venturi in un suo importante saggio; rientrato in Piemonte Vasco pubblicherà nel 1769 l’opera ispirata alle teorie fisiocratiche del Quesnay, La felicità pubblica considerata nei coltivatori delle terre proprie. Nel 1776, un docente dell’Università di Sassari, l’ex gesuita novarese Francesco Gemelli, offriva una trattazione del problema della riforma fondiaria in Sardegna secondo coordinate ispirate alle teorie fisiocratiche, sinonimo di liberismo economico, nell’opera Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura; l’opera sull’assetto fondiario in Sardegna era stata espressamente commissionata al Gemelli dal governo piemontese in vista di una riforma del sistema feudale e della creazione della proprietà perfetta onde incoraggiare l’intraprendenza di una nascente e timida borghesia terriera. Tra il 1774 e il 1777 l’abate Francesco Cetti, anch’egli docente dell’Università di Sassari e seguace del celebre naturalista francese Buffon, autore dell’Histoire naturelle, pubblicava in tre volumi la splendida Storia naturale della Sardegna, impreziosita da pregevoli tavole a colori.
La nuova cultura universitaria era inoltre permeata da una rinnovata sensibilità per la storia patria e da una particolare attenzione in ambito giuridico ai fondamenti e ai fini della società, che traevano ispirazione, oltre che dalla tradizione giusnaturalistica e contrattualistica, dalla grande lezione di Ludovico Antonio Muratori sia sul versante della ricerca storica che su quello della filosofia civile, espressa questa nell’ultima opera del grande intellettuale modenese, Della pubblica felicità oggetto de’ buoni prìncipi, pubblicata un anno prima della morte nel 1749. Rifacendosi espressamente all’opera Rerum italicarum scriptores del Muratori, Domenico Simon aveva iniziato, tra il 1785 e il 1788, la pubblicazione della collana intitolata Rerum sardoarum scriptores, di cui uscirono due volumi, tra cui, significativamente, il breve compendio di Sigismondo Arquer, vittima dell’Inquisizione, Sardiniae brevis historia et descriptio. Esempio significativo del rinnovato impegno civile dell’intellettualità isolana è la letteratura didascalica del secondo Settecento sardo, redatta sia in lingua sarda che italiana, di cui costituisce un esempio il poema giovanile dello stesso Domenico Simon intitolato Le piante (1779).
Questa nuove temperie culturale interagiva, com’è ovvio, con il contesto locale e con le condizioni politiche ed economiche della Sardegna del Settecento: i principi della fisiocrazia e del liberismo economico, applicati alla situazione sarda, comportavano uno scontro decisivo col sistema feudale che costituiva il principale ostacolo per la loro concreta affermazione; l’impegno civile per il riconoscimento della specificità della costituzione del Regno sardo era ostacolato dal sistema coloniale di governo del Piemonte sabaudo, che oltre a vanificare le prerogative costituzionali della nazione sarda, impediva alla nuova intellettualità la concreta partecipazione al governo dello Stato interamente affidato ad una burocrazia esterna famelica e incapace; il rinnovato interesse per la storia consentiva di individuare in un passato lontano una sorta di età dell’oro o di stato di natura in cui la Sardegna viveva arbitra del proprio destino e libera dalle catene del giogo feudale.
La linfa nuova immessa nella cultura compenetratasi con le condizioni oggettive della realtà politica e sociale dell’isola costituì l’elemento motore della nostra rivoluzione; di essa dobbiamo tener conto per comprendere i motivi ispiratori del canto della rivoluzione sarda, che esamineremo nei suoi aspetti essenziali e proponiamo nel testo che nel 1896 il poeta nuorese Sebastiano Satta pubblicò sul quotidiano sassarese La Nuova Sardegna, con traduzione italiana a fronte – non esente da mende e da qualche travisamento di tipo semantico – in occasione del primo centenario della «sarda rivoluzione» e dei moti antifeudali guidati da Giovanni Maria Angioy nel giugno del 1796.
- L’inno «Su patriota sardu a sos feudatarios»: aspetti formali e edizioni ottocentesche
L’inno del Mannu, redatto in sardo logudorese, consta di 47 strofe, ciascuna di otto versi ottonari; la struttura metrica è cioè quella dell’ottava torrada, ossia dell’ottava con ritornello, di lunga tradizione nella poesia in lingua sarda, che usa indifferentemente, secondo le classificazioni metriche date dallo Spano nell’Ortografia sarda nazionale (1842), sia l’endecasillabo che l’ottonario. La scelta dell’ottonario risiede probabilmente nel fatto che tale struttura metrica è la stessa usata nei gosos in onore dei santi, generalmente cantati dalle popolazioni rurali: l’ottonario che ha un ritmo veloce, consente una facile memorizzazione del contenuto ed è particolarmente adatto al canto. Il testo era probabilmente finalizzato al canto; nel canto comunque l’inno ha trovato ampia utilizzazione sia durante la marcia dell’Angioy nel giugno 1796 sia nei secoli successivi sino ai nostri giorni. Considerata la lunghezza dell’inno, le strofe più usate nel canto sono la prima (Procurade ’e moderare / barones sa tiranìa), la ventiquattresima (O poveros de sas biddas / trabagliade trabagliade) e la quarantaseiesima (Custa populos est s’ora / d’estirpare sos abusos), indubbiamente fra le più intense per il pathos emotivo che sono capaci di infondere, cariche di un forte sentimento di ribellione, di protesta, di denuncia, di lotta contro l’ingiustizia: come canto di protesta e di guerra contro le ingiustizie l’inno è stato interiorizzato dall’immaginario collettivo dei sardi.
Lo schema metrico predominante, che interessa 44 strofe su 47, è a – bb – cc – dd – e; non sono cioè legati da rima il primo e l’ultimo, mentre gli altri versi sono legati da rime interne; una curiosità ritmica è costituita dal fatto che per tutto il componimento l’ultimo verso termina in -ia (15 strofe su 47), e in -are (32 strofe su 47).
La non fitta schiera di studiosi che si sono occupati dell’inno non sono d’accordo circa la data di composizione e di pubblicazione, oscillando tra il 1794 (è l’opinione dello Spano) e il 1796 (per questa data propende il Garzia). Si tratta però di proposte di datazione che si basano su testimonianze indirette; un’analisi ab intra del componimento – a giudizio di chi scrive – offre elementi specifici che consentono di individuare particolari episodi del «triennio rivoluzionario sardo» e, conseguentemente, di ipotizzare una datazione meno approssimata. Di ciò si tratterà nella parte finale di questa presentazione dell’inno Procurade ’e moderare.
È comunque sicuro che la prima edizione dell’opera, che fu fatta durante il «triennio», non avvenne in Sardegna; l’inno fu pubblicato clandestinamente in Corsica, verosimilmente attorno alla fine del 1795 e l’inizio del 1796; di questa prima edizione – un piccolissimo volumetto di dodici pagine assai scorretto, secondo Raffa Garzia – la Biblioteca Universitaria di Cagliari dovrebbe possedere tre esemplari. Diverse fonti attestano che l’inno era sicuramente noto nel giugno 1796: esso veniva infatti cantato dall’improvvisato esercito che accompagnò l’Alternos Giommaria Angioy durante la sua «marcia» verso o contro Cagliari (la ricerca storica non è ancora oggi in grado di dire con certezza l’una o l’altra cosa) tra il 2 e il 10 giugno 1796.
Dopo l’esilio dell’Angioy (il capo dei moti antifeudali in Sardegna riparò in Francia e morì a Parigi nel 1808) e la feroce persecuzione degli angioiani, l’inno visse alla macchia, nella tradizione orale e manoscritta; da un esemplare manoscritto lo trasse l’inglese John Warre Tyndale nell’opera The Island of Sardinia del 1849, che lo pubblicò per la prima volta dopo l’edizione corsa del 1796, offrendo anche a fronte la traduzione in versi in lingua inglese. Dalla traduzione inglese del Tyndale il Boullier ricavò nel 1864 la traduzione dell’inno in lingua francese nell’opera di cui si è detto innanzi; particolare curioso, alcune strofe tradotte dal Boullier risultano poeticamente più efficaci che quelle originali. L’inno riceveva infine diritto di cittadinanza in Sardegna solo nel 1865 ad opera del canonico Giovanni Spano, che lo inserì nella raccolta di Canzoni popolari inedite in dialetto sardo centrale ossia logudorese. Da quel momento sino ad oggi l’inno ha avuto larga diffusione a stampa, sebbene attenda ancora l’opera competente del filologo che ne stabilisca il testo critico.
Considerata la lunghezza del componimento, non è semplice districarsi al suo interno. Si delinea in questa sede una sintesi del contenuto e verrà proposta un’ipotesi di datazione.
- I temi centrali dell’inno
Due sono le idee-base che l’inno intende trasmettere: la necessità di porre fine al sistema feudale, o forse sarebbe meglio dire alla sua degenerazione, e quella di denunciare il malgoverno e le vessazioni dei funzionari piemontesi. Due sono anche gli espliciti destinatari: i feudatari e il popolo, in particolare le popolazioni rurali. All’interno delle strategie testuali messe in atto dall’autore i feudatari, bersaglio immediato dell’invettiva e della protesta, rappresentano un interlocutore ‘passivo’ che permette di esplicitare i contenuti ideologici del componimento; i feudatari servono cioè da espediente stilistico che consente l’impiego del discorso diretto, dell’invettiva, giocata sui vocativi e gl’imperativi, che producono un forte coinvolgimento emotivo. In realtà i veri destinatari, che il testo suggerisce nei contenuti ideologici e nelle scelte linguistiche e stilistiche operate, sono le vittime principali dei feudatari, le masse contadine. Sulle masse contadine è concentrato l’impianto stilistico del componimento e la connotazione dottrinaria e didattica di esso. Mentre l’impianto stilistico, in particolare il codice linguistico usato, è rivolto ad ottenere comunione e assenso, quello dottrinario e didattico è volto a produrre competenze nelle masse subalterne, al fine di adeguare in qualche misura la loro “enciclopedia” a quella contenuta nel messaggio, confermandole o conquistandole alla causa della rivolta antifeudale.
L’articolazione dei contenuti, semplificando al massimo, è la seguente:
Fatta nelle strofe 1-3 s’isterrida, ossia la proposizione dell’argomento, che è l’esistenza, in pieno secolo dei lumi, di un istituto anacronistico e vessatorio, il feudalesimo, il poeta inizia l’opera di “rischiaramento” del popolo attraverso la delineazione di una breve storia delle origini del sistema feudale, sorto a seguito di uno squallido mercimonio operato da conquistatori senza scrupoli durante il medioevo – periodo storico definito illuministicamente «età buia» (zega antighedade) – ai danni delle genti libere e sovrane dell’isola di Sardegna (strofe 4-7).
L’età presente, che è l’età dei lumi contrapposta all’età buia, è comunque in grado di porre rimedio a questa forma di “schiavitù”. Dopo aver descritto nella strofa 8 la condizione del vassallo, sottoposto a «milli cumandamentos», cioè ad un’infinità di balzelli che ne rendono insopportabile l’esistenza, segue una disquisizione storico-giuridica circa il carattere violento dell’istituto feudale, contrario alla legge di natura (strofe 9-10).
Il sistema feudale è contrario alla sana speculazione politica e quindi di per sé è illegittimo. Tuttavia il sistema feudale sardo alle origini dovette essere mite. Col passare dei secoli però esso ha subito un progressivo imbarbarimento per l’ingordigia dei feudatari (strofe 11-12). Nonostante il vizio d’origine, sembra suggerire il poeta, qualunque forma di organizzazione sociale può rispondere al fine della società civile, perfino il sistema feudale! Ma la rapacità della classe feudale, interessata solo a percepire censi e a drenare ricchezze, ha impedito e impedisce una corretta amministrazione, che non sarebbe forse impossibile. Funzionale a questa rapacità è la scelta della burocrazia feudale, ignorante e corrotta, che risponde solo all’esigenza di arricchire sè stessa e il feudatario, con la conseguenza di scorticare («iscorzare») i vassalli (strofe 13-17). Il rapporto tra governanti e governati, argomenta il poeta, è un rapporto pattizio, frutto di un contratto originario. Quando uno dei contraenti non rispetta il patto sociale, finalizzato alla difesa dei diritti fondamentali (la vita, la proprietà e implicitamente la libertà), è giustificata la ribellione, anche se il poeta sembra limitarla ad una ribellione di carattere fiscale (strofe 18-19).
Le strofe 20-27 rappresentano, con efficace contrappunto, la giornata del feudatario, gaudente lussuosa e immersa nel vizio, e la giornata del vassallo, stentata faticosa e grama, chiara imitazione di alcune parti del Giorno del Parini. È all’interno di questa descrizione che il poeta, tra la preghiera attonita e l’imprecazione irosa, raggiunge uno dei momenti più alti d’ispirazione lirica e di pathos (strofe 23-24), con cui si chiude la prima parte del poema, dedicata ad illustrare gli aspetti caratteristici del sistema feudale.
A partire dalla strofa 28 l’inno assume una fisionomia storicamente più connotata essendo tutto incentrato sul riferimento agli avvenimenti politici della Sardegna del 1793-1795. Feudatari e governo piemontese hanno disatteso la convocazione delle Corti o Parlamento sardo, prima delle «Cinque domande», ossia della piattaforma unitaria di riforma politica riassunta in cinque richieste, che per volontà della nazione sarda una deputazione stamentaria presentò al sovrano nell’autunno 1793. Scopo della convocazione delle Corti, assemblea legislativa della nazione sarda secondo la costituzione del Regno che non fu mai convocata dal governo piemontese, era quello di predisporre la riforma dello Stato. I membri degli stamenti che chiedevano, a norma del diritto patrio, la convocazione dell’assise parlamentare come sede naturale per avviare l’improcrastinabile riforma degli ordinamenti del Regno di Sardegna, sono stati invece accusati di essere contrari all’istituto monarchico – accusa del tutto falsa – ed hanno corso il rischio di essere massacrati come giacobini, ossia come repubblicani incalliti. Il poeta è tuttavia fiducioso che Dio, come ha salvato la Sardegna e i veri patrioti sardi dall’invasione ‘giacobina’ del 1793, così saprà anche, secondo la bella preghiera del Magnificat, deporre i potenti ed esaltare gli umili (strofe 28-30).
Dopo aver espresso fiducia che la «sarda rivoluzione» approderà a buon fine, il poeta inizia la lunga invettiva contro i piemontesi (strofe 30-43), ai quali i feudatari si sono venduti. I piemontesi si sono comportati in Sardegna da colonizzatori, né più né meno di come i conquistadores spagnoli si sono comportati nei confronti delle popolazioni indigene delle Americhe. Essi si sono arricchiti alle spalle dei sardi: giungevano in Sardegna poverissimi e se ne tornavano in patria titolati, occupavano gli impieghi più lucrosi e le maggiori dignità ecclesiastiche civili e militari, contraevano matrimoni d’interesse. Eppure essi erano generalmente dei malandrini in quanto, come ebbe a scrivere lo stesso viceré Balbiano in un dispaccio al sovrano, il governo piemontese spediva in Sardegna ad occupare gli impieghi persone poco raccomandabili e indesiderate negli Stati di terraferma; gente insomma che perfino la poco civile Russia spedisce in Siberia invece di affidarle incarichi di responsabilità! Conseguenza di questa politica del governo piemontese è stato l’avvilimento della gioventù sarda che, ricca di talenti e di intelligenze, è costretta a vegetare nell’ozio. Quando poi a qualche sardo, generalmente poco dotato, i piemontesi hanno concesso di occupare qualche posto di poco conto, non gli basta lo stipendio per compensare con regali i suoi ingordi protettori. Infatti i piemontesi, come la classe feudale sarda, si propongono lo stesso fine di drenare risorse dalla Sardegna; della prosperità del Regno sardo e della sua corretta amministrazione non interessa loro nulla, anzi, ritengono che non convenga loro promuoverne la prosperità. Questi «bastardi» hanno così rovinato economicamente la Sardegna. Come se ciò non bastasse, ci hanno perfino privato della nostra memoria storica rubando dai nostri archivi e bruciando carte e documenti relativi alla nostra storia ed attestanti i diritti della nazione sarda. L’aiuto del Cielo ha consentito ai Sardi di cacciare via dall’isola questo flagello con l’insurrezione del 28 aprile 1794 e ciononostante i feudatari, che portano in fronte il marchio della fellonia, stanno facendo di tutto per farli rientrare e giovinette di alto lignaggio hanno ripreso a contrarre matrimoni con questi stranieri. Vergogna! Purché non sia sardo le nostre giovani sposano chiunque, anche se si tratta di un nettacessi («bassèri»)!
Noi qui, ospitali com’è nella nostra tradizione, accogliamo questa gente; se invece ad un sardo capita di andare a Torino è costretto a baciare i piedi e il … deretano; per ottenere qualche piccolo privilegio o qualche stemma nobiliare i sardi devono lasciarvi le loro ricchezze, mandando in rovina e casa e patria, e il vero titolo che guadagnano è quello di traditori e spie.
Occorre comunque avere fiducia, dice il poeta avviandosi alla conclusione (strofe 43-47), perché Dio non lascia trionfare il malvagio. Aiutati però, ché il Ciel t’aiuta! Occorre che l’uomo faccia la sua parte nel combattere le ingiustizie. Sardi, svegliatevi – esorta il poeta – seguite la via che vi indico! Il sistema feudale, questo assurdo mercimonio di popoli deve finire! Attenti, perché il mostro sembra voler risollevare la testa. Sardi, non demordete. È questo il momento propizio per portare a fondo la lotta. Popoli, è giunta l’ora di lottare con decisione contro gli abusi, di abbattere i despoti. Guerra, guerra all’egoismo, guerra agli oppressori, disarcionate questi tirannelli, altrimenti, se non profitterete delle circostanze favorevoli, un giorno vi morderete le mani dalla rabbia. Prima che sia troppo tardi, o sardi, passate all’azione: ora che l’orditura è pronta, spetta a voi tessere la tela. Il contadino sa che quando spira il vento propizio, è il momento di lavorare sull’aia, è il momento di separare il grano dalla pula!
5. Aspetti estetici e stilistici dell’inno secondo l’analisi di M. Antonietta Dettori
Abbiamo sin qui fatto le operazioni preliminari ed essenziali di approccio al testo dell’inno, delineandone la genesi, il contesto storico, la comprensione letterale. Faremo ora alcune brevi osservazioni di carattere generale sull’aspetto estetico e stilistico, su cui esiste fortunatamente un recente approfondito saggio che affronta egregiamente il problema utilizzando le moderne metodologie di analisi testuale.
Sotto il profilo estetico, se dovessimo indulgere a un criterio di giudizio di derivazione crociana, come ad esempio hanno fatto lo storico della letteratura sarda Francesco Alziator e lo storico Carlino Sole, dovremmo concludere che la poeticità del componimento è veramente labile, se non del tutto inesistente.
Sarebbe tuttavia errato utilizzare, nella valutazione dell’inno patriottico Procurade ’e moderare, superate categorie estetiche di interpretazione; è necessario invece ricorrere, per formulare un corretto giudizio estetico, ad un tipo di analisi testuale che tenga conto della specificità del componimento, che è fondamentalmente un testo di propaganda politica e di elaborazione ideologica, espressione di quella mobilitazione degli intellettuali nel sociale, che fu un elemento caratteristico dei movimenti rivoluzionari della fine del Settecento, non solo in Sardegna. L’autore non è un letterato di professione, ma un giurista, uno degli intellettuali impegnati sul nuovo fronte ideologico apertosi nella Sardegna di fine Settecento, e che concepisce la sua canzone patriottica non come opera d’arte, ma come contributo alla lotta politica e sociale, che investe la società sarda di quegli anni, contributo che segna il passaggio dal suo impegno personale contro l’ingiustizia dal piano delle idee al piano del concreto coinvolgimento nel sociale.
È con lo sguardo rivolto a queste caratteristiche che occorre affrontare l’analisi ‘estetica’ del componimento. In questo senso ci può essere di valido aiuto un’analisi testuale e un criterio d’interpretazione e di comprensione come la teoria del Bachtin relativa alla stretta correlazione che esiste, in ogni testo letterario, fra ideologia e usi linguistici; oppure ci può essere d’aiuto l’analisi della funzione poetica all’interno delle funzioni del linguaggio suggerita dallo Jakobson nei Saggi di linguistica generale. Sono questi gli strumenti di analisi suggeriti e messi in pratica da Maria Antonietta Dettori, autrice di un saggio molto bello di analisi estetica e stilistica dell’inno di Francesco Ignazio Mannu, apparso sulla rivista “Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico” n. 32-34, intitolato ‘Su patriottu sardu a sos feudatarios’ di Francesco Ignazio Mannu (pp. 267-308), su cui è basata l’analisi stilistica che qui si propone.
La poesia patriottica di questo tipo – scrive M. A. Dettori – al pari degli opuscoli e dei manifesti di propaganda e dei catechismi repubblicani, della produzione teatrale d’indottrinamento popolare (si pensi ai Dialoghi contadini del circolo ambulante di Gionnetti), degli scritti giornalistici, dell’oratoria politica svolta spesso in dialetto, hanno valore di “formazioni discorsive” e produzioni letterarie strettamente correlate alle forme dell’ideologia dominante in quello scorcio di secolo, che è politica e orientata in senso democratico e rivoluzionario. Infatti – conclude la Dettori – nel [nostro] componimento la funzione conativa si intreccia saldamente a quella poetica, orientando il messaggio all’esortazione, attraverso scelte linguistiche finalizzate al coinvolgimento dei destinatari. Sul piano linguistico è ampio infatti l’uso del discorso diretto, strutturato sui modi dell’imperativo e sul largo impiego del vocativo e delle seconde persone: es. Procurade ’e moderare / barones sa tiranìa (procurate di moderare, baroni, la tirannia); O poveros de sas biddas, / trabagliade, trabagliade (O poveri dei paesi, lavorate, lavorate); Custa populos est s’ora / d’estirpare sos abusos (Questa, o popoli, è l’ora di estirpare gli abusi). Sul piano stilistico vengono messe in opera strategie retoriche di presenza e di comunione, volte al coinvolgimento emotivo e pragmatico dell’interlocutore» (pp. 277-78).
Tale interlocutore è, come si diceva, la popolazione rurale e ciò spiega il frequente uso dei proverbi della tradizione contadina, l’uso di un lessico caustico e triviale per descrivere gli avversari di classe, le metafore che utilizzano termini desunti dal lavoro delle campagne e di tipo meteorologico, l’uso frequente delle opposizioni nel delineare le differenti condizioni di vita, ecc.
Sono queste peculiarità stilistiche ed estetiche che hanno contribuito alla fortuna del componimento sia alla fine del Settecento che nei due secoli successivi, producendo una forte interiorizzazione di esso da parte della “nazione” sarda a prescindere dalle classi sociali e dalle differenti situazioni storiche. La “poeticità” di questo canto patriottico sardo non risiede, quindi, sicuramente nella sua perfezione stilistica e formale; risiede invece nella sua funzione conativa e nella sua aderenza all’ideologia di fondo del popolo sardo, in cui la memoria storica e le condizioni del presente hanno contribuito e contribuiscono a creare un’ideologia ribellistica, un’ideologia nella quale la subalternità pesa ancora come un macigno. Non a caso il messaggio contenuto delle strofe dell’inno Procurade ‘e moderare è stato interpretato dai sardi in vari modi, secondo il momento storico particolare, e i versi sono stati utilizzati a dare voce a proteste e a rivendicazioni diverse.
6. Periodo di composizione di «Su Patriota sardu a sos feudatarios”
Ci siamo limitati, per l’analisi testuale, a rimandare al saggio di Maria Antonietta Dettori, del quale sono state delineate le tesi significative.
Resta da affrontare in conclusione un argomento cui si accennava all’inizio, quello del periodo di composizione dell’inno, e quindi indirettamente di pubblicazione. Si tratta di notazioni che chi scrive ha pazientemente raccolto in questi anni, in cui ha concentrato la sua attenzione sul periodo del «triennio rivoluzionario sardo”, e che si fondano sull’analisi ab intra dell’inno.
Si è detto sopra che non vi è concordia tra gli editori e gli studiosi circa il periodo di composizione dell’inno e la data di pubblicazione, anche perché il problema non è stato mai studiato approfonditamente da nessuno. Lo Spano propone, sebbene in modo indiretto, il 1794; Raffa Garzia sembra propendere per il 1796; prima di entrambi, lo storico Giuseppe Manno ricorda l’inno nella sua Storia moderna della Sardegna solo quando tratta dei moti angioiani, nel giugno 1796. Quanti in seguito hanno pubblicato o studiato questo componimento si sono rifatti a questi autori, non dando eccessivo peso al problema.
Il problema della datazione, invece, non è di secondaria importanza; la collocazione il più possibile esatta sotto il profilo cronologico delle problematiche trattate nell’inno e degli eventi che in esso vengono richiamati sono invece fondamentali per la sua adeguata comprensione. È stata la scarsa attenzione a questo problema che ha fatto sì che si siano attribuite a questo testo valenze che non gli appartengono affatto, quale ad esempio quella di assegnargli una presunta parentela col movimento giacobino, assertore di idee democratiche e repubblicane, fino alla definizione, forse gratificante ma storicamente inattendibile, di «Marsigliese sarda»!
Secondo la presente ipotesi la redazione dell’inno risale all’estate – autunno 1795, quando il problema dell’arroganza dei feudatari del Capo di sopra e il problema della mitigazione degli abusi del sistema feudale diventa centrale nel dibattito politico e nelle vicende storiche dell’isola.
Sono fondamentali, per l’ipotesi di datazione che io propongo, le strofe 28-30 dell’inno, che costituiscono come il fulcro attorno al quale è costruita, dal punto di vista cronologico, la narrazione e l’articolazione logica degli argomenti.
Nelle strofe 1-27 l’autore ha narrato, quasi una lunga preparazione per introdurre il lettore al momento storico particolare cui quella narrazione era funzionale, la storia e le caratteristiche sociali, politiche e giuridiche dell’istituto feudale. Nei ventiquattro versi delle strofe 28-31, dopo aver posto l’esigenza di una urgente riforma di quell’istituto barbarico e anacronistico, l’autore offre alcune indicazioni storicamente determinate e contestualizzate, per spiegare il motivo per cui quell’istituto non è stato riformato:
Timende chi si reforment / disordines tantu mannos, / cun manìzos e ingannos / sas Cortes han impedidu / e isperder han querfidu / sos Patricios pius zelantes / nende chi sun petulantes / e contra sa Monarchia.
Ai cuddos, ch’in favore / de sa patria han peroradu, / chi s’ispada hana bogadu / pro sa causa comune, / o a su tuju sa fune / cherian ponner meschinos! / O comente a Giacobinos / los cherian massacrare.
Però su chelu hat deffesu / sos bonos visibilmente, / aterradu hat su potente, / ei s’umile exaltadu. / Deus, chi s’est declaradu / pro custa Patria nostra, / de ogni insidia bostra / Isse nos hat a salvare.
Il primo quesito al quale dobbiamo rispondere è: quando e da chi è stata impedita la celebrazione delle Corti?
Il secondo quesito è: quando e chi ha pensato di disperdere i veri patrioti, che sono stati accusati di essere contrari all’istituto monarchico, dei giacobini desiderosi d’instaurare la repubblica, fino a progettare di massacrarli?
Il terzo quesito è: chi è il potente, o i potenti, che sono stati abbattuti?
Ricapitoliamo brevemente le vicende del 1795 ed avremo la risposta ai quesiti che ci siamo posti.
La richiesta di convocazione delle Corti era la prima delle cinque domande che la delegazione stamentaria portò a Torino nel 1793. Il primo diniego è nel regio biglietto del 1° aprile 1794 in cui è detto, tra l’altro, che le sedute stamentarie potevano continuare per altri sei mesi al fine di proporre alcune riforme particolari,
riservandosi S.M. di permettere poi anche a tempo più opportuno, e sempreché le circostanze di pubblico bene lo richiederanno, la formale celebrazione delle Corti generali ogni qual volta non sia per adottarsi, come più proficuo pe’ motivi rilevati dallo Stamento ecclesiastico nella sessione delli 7 maggio dell’anno scorso, il sistema ivi dal medesimo suggerito.
Questa risposta elusiva, insieme alle altre, aveva provocato la cacciata dei piemontesi il 28 aprile 1794 e il periodo di governo autonomo della Sardegna nell’estate 1794, quando la Reale Udienza governò con i poteri viceregi e con la pressione vigile e determinante degli stamenti e del popolo cagliaritano. Giunto il nuovo viceré Vivalda in Sardegna nel settembre 1794, si rese conto delle improcrastinabilità della convocazione delle Corti per una riforma di cui gli stamenti e le masse urbane reclamavano l’urgenza. Nel giugno 1794 al conte Pietro Graneri era subentrato, nel governo degli affari della Sardegna, il conte Avogadro di Quaregna, che si dimostrò più attento alle richieste dei Sardi e alle pressioni del viceré; con regio dispaccio del gennaio 1795, letto nelle assemblee stamentarie il 5 febbraio, il conte Avogadro comunicava che il sovrano aveva dato il suo assenso per la celebrazione delle Corti, e che al prossimo dispaccio avrebbe fatto pervenire l’atto formale di convocazione. Ciò non avvenne, per cui gli stamenti, nella seduta del 18 marzo 1795 sollecitavano l’adempimento della promessa fatta un mese e mezzo prima.
A Torino però maturavano decisioni nuove e importanti per il governo dell’isola. Alla fine di marzo il sovrano licenziava il conte Avogadro di Quaregna, e affidava l’incarico degli affari di Sardegna ad un nuovo ministro, il conte Galli della Loggia, per nulla propenso ad accogliere le richieste dei Sardi nonché molto incline ad ascoltare l’opinione del marchese della Planargia, che con missive segrete dissuadeva la Corte dal procedere alla convocazione delle Corti, in quanto le assemblee stamentarie erano da lui presentate come un covo di giacobini contrari all’istituto monarchico. Segue nel maggio 1795 una precisa vulnerazione delle leggi fondamentali del Regno ad opera del ministro Galli, con la nomina senza l’uso delle prescritte terne dei nuovi giudici della sala civile della Reale Udienza, che provoca una durissima reazione degli stamenti e successivamente, il 27 maggio 1795 lo stesso conte Galli comunicava che il re, cancellando la promessa del mese di gennaio, aveva deciso di sospendere la celebrazione delle Corti.
Il Planargia e il Pitzolo attraverso i loro maneggi presso i dicasteri torinesi, avevano avuto partita vinta. Alle proteste degli stamenti, dei giudici “patrioti” della Reale Udienza e del popolo cagliaritano, il marchese della Planargia e il Pitzolo, che rappresentavano l’oltranzismo del partito dei feudatari più retrivi, rispondevano approntando liste di proscrizione dei fautori dell’anarchia o giacobini, come li chiamavano, e ne invocavano il processo sommario e la condanna a morte per alto tradimento in quanto presunti fautori di un fantomatico partito contrario all’istituto monarchico. Stamenti e popolo chiedono la destituzione dei due; di fronte alle titubanze del viceré e dopo che vengono scoperte le loro trame, i due alti funzionari vengono trucidati, Pitzolo il 6 e Planargia il 22 luglio 1795.
In quanto abbiamo succintamente narrato è la spiegazione dei tre quesiti che ci siamo posti: la responsabilità della mancata convocazione delle Corti è del ministro Galli e dei due alti funzionari sardi, esponenti dell’oltranzismo feudale, che accusando di giacobinismo i «Patrizi [scil. patrioti] più zelanti», ossia quanti volevano semplicemente l’applicazione delle leggi fondamentali del Regno, volevano annientarli; tali nemici della patria però erano stati abbattuti, cioè assassinati.
Dopo l’assassinio dei due esponenti del partito feudale, i feudatari del Capo di Sassari danno luogo ad un’autentica secessione del Capo settentrionale, secessione avallata sempre dal conte Galli con due regi biglietti del 29 agosto 1795, in virtù dei quali la Reale Governazione di Sassari viene praticamente autorizzata a non eseguire gli ordini viceregi: si viene a creare una nuova alleanza tra feudatari e governo piemontese, come vien detto nella strofa 31, che non a caso introduce la lunga invettiva contro i piemontesi, la cui cacciata dall’isola, come si desume da tutto il contesto, appare come un fatto acquisito, rimesso in discussione appunto dal «perfido feudatario» per interesse personale, ossia per conservare una impossibile situazione di privilegio, non già per amore della costituzione del Regno sardo. La perfidia dei feudatari sassaresi consiste proprio nell’aver tradito le motivazioni che stavano alla base dell’insurrezione cagliaritana del 28 aprile 1794: la rivendicazione dello statuto speciale della Sardegna nell’ambito degli stati sabaudi, il riconoscimento di un’identità politica e culturale. È questo tradimento che ispira all’autore dell’inno il sarcasmo e l’invettiva contro i piemontesi, quasi a voler rammemorare con tinte forti quanto ad ogni sardo, per riprendere un’espressione del Machiavelli, «puzza questo barbaro dominio».
Perfidu feudatariu! / Pro interesse privadu / protettore declaradu / ses de su piemontesu. / Cun issu ti fist’intesu / cun meda fazilidade;/ isse papàda in zittade, / e tue in bidda a porfia.
La secessione dei feudatari sassaresi è osteggiata e combattuta dal “partito patriottico”, che persegue un disegno politico riformista in seno alle assemblee degli stamenti, un disegno politico avallato dal governo viceregio e dalla Reale Udienza; nei mesi di agosto e di settembre stamenti e governo avevano emanato due provvedimenti in cui invitavano le ville ad una pacifica composizione del contenzioso con i rispettivi feudatari circa i tributi esatti illegittimamente. Tale linea politica era condivisa dalle ville infeudate, che proprio in quei mesi furono protagoniste di un estesissimo moto di ribellione, che se registrò anche manifestazioni violente di saccheggio delle residenze baronali, s’incanalò essenzialmente in una forma di protesta legale contro l’istituto feudale, con il rifiuto di pagare i tributi. Il moto di contestazione delle ville nel Logudoro, contrastato in ogni modo dalla feudalità sassarese, contribuiva così a corroborare l’azione “legale” di soluzione della crisi proposta dagli stamenti e dal governo viceregio.
Per far applicare le disposizioni stamentarie e viceregie che incoraggiavano una composizione legale delle vertenze, il viceré fu costretto alla fine di ottobre a mandare per tutta l’isola tre delegati incaricati di verificare che nelle curie dei villaggi dei diversi feudi fossero affisse e rese di pubblico dominio le determinazioni del governo, pervicacemente osteggiate dal Governatore di Sassari e dai feudatari. L’azione antifeudale assume dunque una chiara connotazione legale; e legale intendeva essere l’abrogazione del sistema feudale, proposto per la prima volta dalle ville di Thiesi, Bessude e Cheremule col famoso strumento di unione e di concordia stipulato davanti ad un pubblico notaio, con cui, si legge tra l’altro nell’atto notarile:_
le suddette ville hanno unanimemente risoluto, e giurato di non riconoscere più alcun feudatario, e quindi ricorrere prontamente a chi spetta per esser redente pagando a tal effetto quel tanto, che da’ superiori sarà creduto giusto, e ragionevole” (cfr. Luigi Berlinguer, Alcuni documenti sul moto antifeudale sardo 1795-96, in AA.VV., La Sardegna nel Risorgimento. Antologia di saggi storici, Sassari 1962, pp. 123-24).
Dopo questo periodo gli “strumenti di unione” si moltiplicheranno in tutto il Logudoro e il riscatto dei feudi tramite indennizzo, non l’abolizione violenta e cruenta del feudalesimo, diventerà la vera parola d’ordine della rivolta antifeudale delle campagne.
È questo il contesto storico e politico-ideologico in cui si inserisce l’inno patriottico di Francesco Ignazio Mannu. Invano si cercherebbe in esso l’incitamento alla rivoluzione cruenta: il tono complessivo dell’inno, anche nei passaggi più concitati, anche quando esplode l’ira contro la schiavitù feudale, i toni non oltrepassano mai i termini di una composizione ragionevole dello scontro sociale. Procurade ’e moderare, avverte in apertura l’inno, a voler significare che se si tira troppo la corda, chi comanda viene disarcionato, e che la via maestra è quella della moderazione, non della contestazione globale del sistema. E anche quando, nella strofa 46, il sentimento d’ira raggiunge l’apice, l’incitamento assume ancora un significato di composizione possibile dello scontro sociale: il poeta infatti non incita alla lotta armata e cruenta contro i feudatari, ma chiede ancora di «estirpare gli abusi», di abrogare le «cattive usanze», che altro non sono che i diritti controversi o illegittimi introdotti dalla prepotenza dei feudatari («su dispostismu»); viene con forza dichiarata guerra all’egoismo e agli oppressori; la guerra cioè deve essere portata contro le persone e le cattive qualità morali di esse non necessariamente contro il sistema; i «piccoli tiranni» occorre «umiliarli», non sopprimerli! Il riferimento ai «tirannos minores», i feudatari, è oltremodo significativo per comprendere la visione politica dell’autore e la valenza della «sarda rivoluzione»: non vi è l’incitamento ad abbattere il “grande tiranno”, cioè il sovrano, l’istituto monarchico, che resta il reggimento politico ideale. Come il poeta ci aveva avvertito nelle strofe 28 e 29, il patriota sardo non si contrappone all’istituto monarchico, non è un giacobino né un repubblicano. L’inno patriottico sardo non si muove dunque nell’alveo di una rivoluzione giacobina, di un programma politico teso ad instaurare una repubblica sarda, come pure è stato più volte adombrato e scritto. Ciò va detto per il rispetto della verità storica, con buona pace di chi ha creduto di vedere nell’inno patriottico sardo una «Marsigliese sarda». È sufficiente un semplice raffronto del nostro inno con l’inno nazionale francese per rendersi conto che l’inno antifeudale non incita alla guerra armata della nazione contro la tirannia, cioè contro i troni dei despoti d’Europa; non individua il fondamento della società civile negli immortali principi dell’Ottantanove, nella libertà individuale, nell’uguaglianza sociale, nella fratellanza universale.
Ciò non significa affatto che l’inno patriottico sardo non sia un inno rivoluzionario, non sia l’espressione di un momento epico della storia del popolo sardo, non sia l’evocazione di una rivoluzione reale per quanto non coronata dal successo. Si vuol semplicemente dire che è l’inno di una rivoluzione nazionale che ha tratti specifici, che non ha bisogno di essere rivestita di panni altrui; è l’inno di una rivoluzione che esprime la specificità della situazione sarda nel Settecento; è l’inno di una rivoluzione patriottica, non giacobina, che rientra a pieno titolo nell’ambito dell’Europa del secolo dei lumi; se è consentito concludere col titolo dell’opera di Franco Venturi, il grande storico dell’illuminismo italiano che più d’ogni altro ha contribuito col suo insegnamento a Cagliari e con due fondamentali saggi a suggerire un’interpretazione storicamente corretta della Sardegna nel secolo XVIII, Su patriota sardu a sos feudatarios è l’inno di una delle tante rivoluzioni germinate nella temperie culturale e politica del Settecento riformatore.
Bibliografia essenziale
Per un inquadramento generale del periodo con ampio corredo bibliografico cfr. F. VENTURI, Settecento riformatore, 5 voll. Torino, Einaudi, 1969-1990; G. SOTGIU, Storia della Sardegna sabauda, Roma-Bari, Laterza, 1984; C. SOLE, La Sardegna sabauda nel Settecento, Sassari, Chiarella, 1984; I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno, Torino, Giappichelli, 1992; Storia de’ torbidi occorsi nel Regno di Sardegna dal 1792 in poi. Opera anonima del sec. XVIII, a cura di L. Carta, Cagliari, Edisar, 1994; G. RICUPERATI, Il Settecento in AA.VV., Il Piemonte sabaudo, vol. VIII, tomo 1, della Storia d’Italia diretta da G. GALASSO, Torino, Utet, 1994, pp. 439-904; Francia e Italia negli anni della Rivoluzione, a cura di L. Carta e G. Murgia, Roma-Bari, Laterza, 1995; A. MATTONE- P. SANNA, Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell’Antico Regime, Milano, F. Angeli Editore, 2007.
Sull’inno antifeudale di F. I. Mannu, cfr. R. GARZIA, Il canto d’una rivoluzione, Tip. dell’Unione Sarda, Cagliari, 1899; P. A. BIANCO-F. CHERATZU, Su patriottu sardu a sos feudatarios di Francesco Ignazio Mannu, Condaghes, Cagliari, 1991; M. A. DETTORI, Su patriottu sardu a sos feudatarios di Francesco Ignazio Mannu, in “Archivio Sardo del Movimento Operaio Contadino e Autonomistico”, n. 32-34, pp. 267-380; L. MARROCU, Procurad’ ‘e moderare. Racconto popolare della Rivoluzione sarda, 1793-1796, AM&D Edizioni, Cagliari 1996; F. I. Mannu, Su patriota sardu a sos feudatarios, a cura di Luciano Carta, Cagliari, Centro Studi Filologici/Cuec, 2002 (2a Ed. 2006).
Parte Terza
Traduzione italiana e Commento dell’inno “Procurade ’e moderare barones sa tiranìa”
roemio
Messaggio, avvertimento, minaccia ai baroni o feudatari (strofe 1-3).
Le prime tre strofe costituiscono una sorta di proemio che delinea l’argomento del carme.
1.
Procurade ’e moderare
Barones sa tiranìa,
Chi si no pro vida mia
Torrades a pè in terra.
Declarada est già sa gherra
Contra de sa prepotenzia
E cominzat sa passienzia
In su populu a faltare.
Cercate di moderare, baroni, la tirannia, altrimenti, lo giuro sulla mia vita, tornate a piedi a terra! È già dichiarata la guerra contro la prepotenza, e nel popolo la pazienza comincia a venir meno.
2.
Mirade ch’est azzendende
Contra de bois su fogu,
Mirade chi no est giogu,
Chi sa cosa andat de veras,
Mirade chi sas aeras
Minettana temporale;
Zente consizada male,
Iscultade sa oghe mia.
Badate che si sta accendendo l’incendio contro di voi; badate che non è uno scherzo, che la cosa sta diventando realtà; badate che il cielo minaccia il temporale; gente mal consigliata, ascoltate la mia voce.
3.
No appretedes s’isprone
A su poveru runzinu,
Sinò in mesu caminu
S’arrempellat de appuradu,
Minzi ch’est lanzu, e cansadu
E no nde podet piusu
Finalmente a fundu in susu
S’imbastu nde hat a bettare.
3. Non incalzate con lo sprone il povero ronzino, altrimenti si ribella in mezzo alla strada; vedete com’è magro e spossato e non ne può più; finirà per rovesciare a terra a gambe all’aria il basto [che è poi il cavaliere che monta il ronzino!].
Le prime due strofe dell’inno, con accenti esortativi e insieme minacciosi, si propongono di far prendere coscienza al feudatario che il clima dei rapporti sociali è profondamente mutato: i vassalli, stanchi delle angherie e dei soprusi, hanno dichiarato la guerra contro di essi e non sono più disposti a subire le prepotenze dei baroni. Esortazioni e minacce si susseguono in un crescendo di immagini di grande efficacia (l’evocazione dell’imminenza dell’incendio, il rischio concreto che il cavaliere venga disarcionato e ridotto a semplice fantaccino, lo stato di guerra dichiarato e irreversibile, l’imminenza dell’uragano), sottolineate nella seconda strofa dall’iterazione dell’imperativo mirade, ‘badate’.
La metafora della strofa 3 del cavaliere (il feudatario) e della cavalcatura (i vassalli), il cui rapporto, per essere armonico, deve essere in simbiosi, oltre ad essere coerente con il contesto, che è il mondo contadino per il quale questo rapporto è vitale, risponde anche allo sforzo di mediazione tra i due componenti della metafora, che riassume in sé la struttura sociale dell’epoca: la cavalcatura, cioè i vassalli non devono essere trasformati in mera bestia da soma. Il motivo della mediazione costituisce uno dei temi portanti dell’inno perché in un tentativo di mediazione risiede in fondo la rivoluzione sarda e la lotta del movimento antifeudale angioiano. Si noti, però, che sotto la metafora della cavalcatura trasformata in bestia da soma, in realtà il poeta abbia inteso simboleggiare il vero protagonista della ribellione contro la prepotenza feudale: il popolo sardo. Su questo protagonista, che compare già al termine della prima strofa, sulla presa di coscienza della sua condizione servile e sulla sua volontà di riscatto, è incentrato il lungo excursus sull’iniquità del sistema feudale che inizia con la strofa 4 e termina con la strofa 27.
II
Descrizione del sistema feudale: analisi storica, giuridica, politica e sociale del sistema feudale sardo (strofe 4-27).
L’argomento centrale dell’inno, che nel quadro delle vicende della Sardegna di fine Settecento si colloca nella parte finale del “triennio” – tra l’assassinio del Pitzolo e del Panargia nel mese di luglio e il contenzioso antifeudale delle “ville” tra agosto e dicembre 1795 – viene delineato nei suoi molteplici aspetti. Soprattutto viene chiaramente indicato lo strumento di lotta attraverso il quale i patrioti sardi ritengono debba essere abolito il sistema feudale, attraverso i “Patti di unione e di concordia” che implicano l’abolizione del sistema tramite indennizzo dei feudatari, titolari della giurisdizione feudale.
4.
Su Populu, ch’in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente despertadu
S’abbizat ch’est in cadena,
Ch’istat sufrende sa pena
De s’indolenzia antiga,
Feudu, legge inimiga
A bona Filosofia!
Il popolo, che era sprofondato in un profondo letargo, finalmente si è risvegliato e si rende conto che è in catene, che sta scontando la pena della sua ormai secolare volontà di reagire contro il sistema feudale, ordinamento [politico e sociale] contrario alla saggezza di una sana speculazione filosofica.
Inizia, con la strofa 4, il lungo excursus di carattere storico-giuridico sulla natura, l’origine e la realtà del sistema feudale. Il ragionamento di carattere giuridico è inserito dal poeta nella trattazione di carattere storico e in quella riferita alla realtà contemporanea: la mancata osservanza dei principi giuridici costituisce, nell’argomentazione del Mannu poeta-giurista, la causa prima dell’iniquità del sistema feudale, come dimostra quando contesta l’arbitrarietà dei titoli d’infeudazione che discende dalla loro illogicità sotto il profilo giuridico (strofe 9-10, 12), oppure quando ricorda il vero fine del prelevamento fiscale (strofe 14 e 17-18), o ancora quando sottolinea l’origine patrizia di ogni società in cui ciascuno dei contraenti è sottoposto ad obblighi reciproci che, se disattesi, rendono legittima la rescissione del contratto (strofa 19). Il ragionamento giuridico è a sua volta fondato e sorretto da una filosofia politica che costituisce il bagaglio culturale di un intellettuale sardo pienamanente partecipe delle idealità e delle aspirazioni del secolo dei Lumi. È fondandosi sui principi di questa sana filosofia del progresso (la bona Filosofia del v. 4.8) che il poeta si impegna in un’azione di “rischiaramento” del popolo, il quale, in virtù di essa, si risveglia dal letargo in cui si trovava immerso e scuote dalla sua mente la secolare caligine ereditata dall’età buia (la zega antiguedade del v. 7.6). In questo modo i singoli e la collettività riacquistano piena dignità di persone e di popolo: obiettivo che è solennemente riaffermato alla fine dell’inno, nella strofa 45, che costituisce, per così dire, la conclusione del ragionamento storico-filosofico, prima delle energiche incitazioni finali che invitano sos populos, ‘le popolazioni’, a passare all’azione in nome, appunto, di quei principi dettati dalla filosofia dei Lumi.
5.
Che chi esseret una binza,
Una tanca, unu cunzadu,
Sas Biddas hana donadu
De regalu, o a bendissione;
Comente unu cumone
De bestias berveghinas
Sos homines, e feminas,
Han bendidu cun sa cria.
Nei tempi in cui in Sardegna è stato introdotto il feudalesimo, i governanti] hanno regalato o venduto i villaggi come se si trattasse di un vigneto, di un tancato e di un chiuso; hanno venduto come un gregge di pecore uomini e donne con tutti i loro figli.
Si noti come il poeta scriva di norma con la lettera maiuscola i termini indicanti entità sociali (Biddas, Populu/os, Populassiones, Sarda Zenia, Sardu/os, Familias, Marchesa, Cittade, Giacobinos, Patria, Piemontensu/os, Camereri, Cavaglieri, Toga, Ispada, Zente, Gioventude, Furisteri), autorità politiche e amministrative (Barone, Feudatariu, Offissiale, Procuratore, Notariu, Podatariu, Capellanu, Vassallu), istituzioni (Feudu, Logu, Giustissia, Cortes, Monarchia, Cheia, Guvernu, Regnu, Archivios, Ministru), figure anche metaforiche e concetti (Tiranu, Segnore per ‘feudatario o barone’, Patricios, Chelu, Filosofia, Mundu, Humanidade) ai quali attribuisce particolare rilevanza e che sono, per così dire, i personaggi e le comparse impegnate nell’azione scenica, imperniata su una lunga orazione accusatoria di un avvocato o di un giudice impegnato a dimostrare che il feudalesimo è nel diritto e nel fatto un’istituzione iniqua. È in questa cornice da atto giudiziario che si svolge l’azione e che intervengono i numerosi personaggi. Sas Biddas, le ville o comunità dei villaggi, identificate spesso con su Populu, ‘ il popolo’, sono tra i principali protagonisti: sono esse, secondo la filosofia giuridica del poeta-giudice, i titolari del diritto di proprietà della terra, bene fondamentale e irrinunciabile dell’antica società rurale della Sardegna. La violazione di questo diritto originario delle comunità di villaggio, che le abilitava ad essere uno dei due contraenti del patto sociale in cui consiste il sistema feudale, ha reso l’introduzione del feudalesimo un atto giuridicamente non valido, e perciò stesso arbitrario, unilaterale e violento, che giustifica e legittima, come argomenta a lungo il poeta nelle strofe successive, la ribellione in atto contro i feudatari, che non possiedono titoli legittimi per governare. Si noti come l’attore della devoluzione dei legittimi beni de sas Biddas resti volutamente indefinito (hana donadu, hana bendidu), a significare sul piano giuridico l’inesistenza di fatto di un regolare contratto, da cui consegue l’arbitrarietà e la violenza del potere esercitato dai feudatari.
6.
Pro pagas mizas de liras,
E tale orta pro niente
Isclavas eternamente
Tantas Populassiones
E migliares de persones
Servin a unu Tiranu.
Poveru generu humanu!
Povera Sarda Zenìa!
[È così che] tante popolazioni [rurali] sono state rese eternamente schiave per poche migliaia di lire e talvolta anche per niente; [è così che] migliaia di persone sono state costrette a diventare schiave di un tiranno. Povero genere umano, povera schiatta dei Sardi!
Il tema della ‘tirannia feudale’, annunciata nella prima strofa, trova qui un ulteriore sviluppo, che ne spiega meglio le conseguenze: essa ha portato alla riduzione in schiavitù delle popolazioni infeudate, poste alla mercé di un tiranno. Vi è stato chi, come il Garzia, ha voluto cogliere in questa strofa improbabili accenti repubblicani e antimonarchici dell’inno. È chiaro dal contesto che il tiranno è colui che ha beneficiato dell’illegittimo mercimonio delle popolazioni, cioè il feudatario o barone, mentre non vi è il minimo riferimento al reggimento politico dello Stato, sia esso monarchia o repubblica. Come il poeta dirà esplicitamente in altra parte dell’inno, il patriota sardo protagonista della lotta antifeudale di fine Settecento respinge la qualifica di repubblicano e si professa sincero suddito dell’istituto monarchico (vedi la strofa 28).
7.
Deghe o doighi Familias
Si han partidu sa Sardigna,
De una manera indigna
Sinde sun fattas pobiddas,
Divididu si han sas Biddas
In sa zega antiguedade,
Pero sa presente edade
Lu pensat remediare.
[Così è potuto accadere che] dieci o dodici famiglie [di feudatari] si sono spartita la Sardegna, se ne sono appropriate in un modo indegno; [durante il Medio Evo], nell’età buia, si sono spartiti i villaggi; [però] l’età contemporanea, [il secolo dei Lumi] farà in modo di porre riparo [a tanta ingiustizia].
I riferimenti storici sull’introduzione del sistema feudale in Sardegna sono delineati in termini molto generici: nell’età buia, cioè durante il basso medioevo, agli inizi del secolo XIV, con la conquista aragonese iniziata nel 1323 dall’infante Alfonso, la Sardegna viene integralmente feudalizzata. Le dieci o dodici famiglie di feudatari di cui parla il poeta hanno valore simbolico, per significare che il territorio dell’isola fu diviso tra pochi feudatari. In realtà già nella metà del sec. XIV “su un totale di 67 feudatari di provenienza catalano-aragonese, solo 7 (il 10%) erano signori di più di 10 villaggi ciascuno, e tra essi si staccano di netto i due Carroz, Berengario e Giovanni, rispettivamente con 40 e 17 villaggi; il 36% controlla tra meno di 9 e più di 2 villaggi; il restante 55% possedeva chi due, chi, i più, un solo villaggio” (B. Anatra, La Sardegna medioevale e moderna, cit., p. 264). L’indicazione è, dunque, volutamente generica perché al poeta non interessa tanto definire in termini quantitativi il fenomeno della frammentazione territoriale portata dal feudalesimo, quanto contrapporre illuministicamente l’età buia (sa zega antiguedade) all’età dei Lumi (sa presente edade): quest’ultima, con gli strumenti della ragione, del diritto e della coscienza popolare, sarà capace di porre riparo alla situazione di schiavitù e di servaggio del popolo sardo.
Che la trasmissione di questo messaggio alle popolazioni sarde sia il precipuo fine dell’inno, lo si può desumere anche dal significativo silenzio sulla resistenza dei giudici d’Arborea, Mariano IV ed Eleonora, alla conquista aragonese: era infatti legittimo, dopo che il poeta aveva delineato il periodo storico in cui nasce il feudalesimo in Sardegna, attendersi almeno un breve cenno sull’argomento. Invece, sulla lunga resistenza armata arborense, il silenzio del Mannu – ma, aggiungiamo noi, quel silenzio non fu solo del Mannu – è assoluto. Il mito romantico dell’eroina d’Arborea era, alla fine del Settecento, ancora di là da venire.
8.
Nasquet su Sardu suggettu
A milli cumandamentos,
Tributos, e pagamentos
Chi faghet a su Segnore
In bestiamen e laore,
In dinari e in natura,
E pagat pro sa pastura,
E pagat pro laorare.
Ogni Sardo fin dalla nascita è sottoposto a mille comandamenti dominicali, che [consistono in] contribuzioni obbligatorie e tasse che è costretto a corrispondere al signore feudale sotto forma di bestiame e di frumento, in denaro e in natura, [cosicché] paga per il pascolo come paga per la semina e il raccolto.
I diritti feudali erano di tre tipi: personali, reali e giurisdizionali. Con i termini cumandamentos, tributos, pagamentos, più che una esatta classificazione, il poeta intende dare un’esemplificazione di questi generi di balzelli, per cui con i cumandamentos è probabile voglia far riferimento alle prestazioni personali del genere delle corvées, con i tributos è probabile intenda riferirisi ai balzelli che si pagavano in natura e con i pagamentos a quelli riscossi in denaro. Dai versi successivi si evince che il messaggio che il poeta intende trasmettere è che i diritti feudali incidono soprattutto sulle due fondamentali fonti di reddito del vassallo, l’agricoltura e la pastorizia.
9.
Meda innanti de sos feudos
Existiana sas Biddas,
E issas fini pobiddas
De saltos e bidatones
Comente a bois Barones
Sa cosa anzena passàda?
Cuddu chi bos l’hat donada
No bos la podiat dare.
Le comunità rurali esistevano ben prima dei feudi ed esse erano padrone assolute dei salti e delle vidazzoni: [ciò considerato], com’è che la proprietà altrui veniva assegnata a voi baroni? Chiunque sia colui che ve l’ha regalata, non poteva [legittimamente] farlo.
Viene ripreso in questa strofa e argomentato sotto il profilo giuridico un principio espresso nei suoi lineamenti storici nelle strofe precedenti. Feudos e Biddas risultano, sotto il profilo giuridico, due realtà antitetiche e conflittuali: poiché il diritto originario di proprietà della terra appartiene alle comunità di villaggio, il trasferimento di quel diritto ai feudatari è arbitrario e illegittimo perché non è provato storicamente che vi sia mai stata una volontà di alienazione di quei beni da parte dei legittimi proprietari. Chiunque si sia arrogata la facoltà di alienare quei beni ha compiuto un atto arbitrario e giuridicamente privo di effetto. Non è possibile dimostrare con argomenti razionali come sia potuto accadere che la proprietà altrui (sa cosa anzena) sia stata ritenuta effettivamente trasferita ai feudatari in assenza di una esplicita volontà di uno dei due contraenti: la comunità di villaggio appunto.
10.
No est cosa presumibile
Chi voluntariamente
Appat sa povera zente
Cedidu a tale derettu;
Su titulu ergo est infettu
De s’infeudassione,
Ei sas Biddas rexone
Tenene de l’impugnare.
[Infatti] è impossibile partire dal presupposto che la povera gente abbia ceduto di sua libera volontà a ciò che le competeva di diritto; [se quella premessa è falsa,] ne consegue che gli atti d’infeudazione, [in quanto discendono da un vizio originario di illegittimità], sono illegittimi e le comunità rurali hanno tutte le ragioni per impugnarli legalmente.
Con la strofa 10 il poeta conclude il ragionamento giuridico sulla legittimità dell’istituzione feudale: trattandosi di un’istituzione di carattere pattizio, l’illegittimità risiede nel fatto che alla regolarità del contratto è mancata la condizione essenziale, cioè l’assenza di uno dei contraenti, le comunità di villaggio.
È assai singolare, sotto il profilo strettamente storico-giuridico, che il poeta riconosca a tutti gli effetti la titolarità di ‘contraenti’ ai villaggi; storicamente l’infeudazione è una concessione, cui conseguono degli obblighi – e in questi obblighi consiste il patto – fatta dal sovrano al feudatario, mentre le comunità o i singoli, legati in qualità di ‘servi’ al territorio, sono, al pari dei beni immobili, oggetto del patto, non soggetti contraenti. È questo un aspetto tutto particolare della tradizione giuridica sarda cui occorre prestare attenzione per comprendere il punto di vista del poeta e alcuni presupposti teorici di non secondaria importanza della sollevazione antifeudale delle campagne del Logudoro nel 1795-96. Ma a prescindere dalla particolare filosofia che sottende questa specie di anomalia giuridica, non occorre dimenticare, come è stato giustamente osservato, che l’inno del Mannu è fondamentalmente un manifesto di propaganda antifeudale che deve far leva sugli argomenti di più facile presa sul pubblico cui è rivolto, un pubblico non in grado di seguire in tutti i suoi particolari gli amminicoli delle argomentazioni del giurista. Al contrario, l’affermazione che le comunità di villaggio sono le originarie titolari del diritto di proprietà delle terre è sicuramente un argomento che ha una forte capacità di coinvolgimento delle popolazioni rurali. Proprio questa rivendicazione sta all’origine del più importante strumento ‘legale’ adottato dalle ‘ville’ del Logudoro nel cuore della lotta contro i feudatari tra l’autunno 1795 e la prima metà del 1796: i cosiddetti “strumenti di unione e di concordia”, pubblici atti notarili con i quali le ‘ville’ che facevano parte di un feudo giuravano di non voler più sottostare ai feudatari, dalla cui giurisdizione dichiaravano di volersi riscattare pagando un equo indennizzo. Proponevano in pratica l’abolizione dei feudi tramite indennizzo, come farà Carlo Alberto quarant’anni dopo. L’argomento del diritto originario delle ‘ville’ è sostenuto con forza anche nel più importante pamphlet antibaronale apparso nel periodo: L’Achille della sarda liberazione.
11.
Sas tassas su principiu
Exigiazis limitadas,
Dae pustis sun andadas
Ogni die aumentende
A mesura chi creschende
Sezis andados in fastu
A misura ch’in su gastu
Lassezis s’economia.
[Ma anche prescindere da quest’argomentazione di carattere giuridico, risulta storicamente che,] durante i primi tempi in cui fu introdotto il sistema feudale esigevate le tasse in misura limitata [e ragionevole]; poi, con il passare del tempo, sono aumentate di giorno in giorno, di pari passo con il crescere del lusso, mano a mano che abbandonavate la parsimonia in favore della prodigalità, [mano a mano che invece di economizzare vi siete dati alle spese pazze].
Dopo le argomentazioni de jure sulla legittimità dei titoli d’infeudazione, il poeta-giurista passa ora ad esaminare gli argomenti de facto, come ad imitare la sequenza argomentativa caratteristica di una sentenza o di una memoria legale. Le considerazioni sviluppate nel ‘fatto’ è come se fossero articolate su uno schema argomentativo di questo tipo: ammesso, e non concesso, che il feudo sia legittimo dal punto di vista giuridico, le conclusioni che possono trarsi dal comportamento concreto e storicamente accertato dei feudatari conducono egualmente ad emettere un verdetto di colpevolezza e di condanna. L’analisi dei ‘fatti’ inizia con l’esame dell’aspetto fiscale: inizialmente il sistema feudale fu sostanzialmente ‘mite’; in seguito, col crescere del lusso (il tema del lusso è tipico della cultura illuministica), è divenuto vessatorio.
12.
Nè bos balet allegare
S’antiga possessione;
Cun minetas de presone,
Cun gastigos, e cun penas
Cun cippos, e cun cadenas
Sos poveros ignorantes
Deretos exorbitantes
Hazis forzadu a pagare.
[D’altra parte] non serve neppure che invochiate [come argomento a vostro favore] l’antichità del possesso, [poiché l’illegittimità del titolo è comprovato anche dal fatto che] avete imposto ai poveri ignoranti la corresponsione di diritti feudali esorbitanti [in modo violento], con minacce di prigionia, [infliggendo loro] castighi e pene, mandandoli in ceppi e in catene.
La strofa 12 la si deve intendere come conclusione del ragionamento avviato nella seconda parte della strofa precedente. È come se il poeta, nella fictio di un ideale contraddittorio con il difensore della causa dei baroni, fosse costretto a rispondere ad un’obiezione di questi tipo: anche se non è possibile dimostrare la legittimità dei titoli d’infeudazione, il possedimento ab antiquo del feudo e l’esercizio storicamente provato della giurisdizione rende ‘de facto’ legittima la proprietà del feudo e l’esercizio del potere. Risponde il poeta: l’argomento è anche ammissibile, però a condizione che i baroni avessero esercitato la loro giurisdizione in termini di mitezza, come avveniva nei primi tempi in cui l’istituto feudale fu introdotto. Questo argomento della legittimità ‘de facto’, come per usucapione, del possesso del feudo non ha valore in quanto il potere è stato esercitato violentemente; voi baroni avete sempre effettuato le esazioni fiscali con la minaccia della carcerazione e con l’irrogazione di sanzioni; voi avete costretto dei poveri ignoranti, circostanza che aggrava di molto il vostro operato, a pagare balzelli che andavano oltre ogni misura rispetto alle capacità contributive dei vassalli. Dunque siete in ogni caso colpevoli.
13.
A su mancu s’impleeren
In mantener sa Giustissia
Castighende sa malissia
De sos malos de su Logu;
A su mancu disaogu
Sos bonos poteren tenner
Poteren andare e benner
Seguros peri sa via.
[Ma passi anche la violenza] se [i balzelli esorbitanti] fossero impiegati almeno per assicurare una buona amministrazione della giustizia, per colpire la malvagità dei delinquenti del paese; [se almeno fossero impiegati] perché gli onesti ne potessero trarre giovamento, perché potessero sentirsi sicuri nell’andare e nel tornare per la strada.
Nell’argomentazione dell’accusa il poeta-giudice enumera le prove in modo da rendere sempre più evidente e stringente la colpevolezza dell’accusato. Dopo aver dimostrato l’illegittimità de jure e de facto del governo feudale, in questa strofa egli, facendo finta di soprassedere alle due precedenti fattispecie di addebito, mostra di essere anche disposto a dare un qualche riconoscimento al sistema feudale, a condizione che la pressione fiscale, pure estremamente esosa, venga utilizzata per garantire la sicurezza dei contribuenti. È come se il poeta, assumendo le vesti di un consumato uomo di governo, dicesse: riconosco che nell’attività di governo una forte pressione fiscale non è da escludere, a condizione però che ne sia chiara la finalità del bene pubblico, come specificherà meglio nella prima parte della strofa successiva. Non è questo, evidentemente, il caso dell’amministrazione feudale, dove l’ingordigia dei feudatari distrae le risorse pubbliche verso fini impropri.
14.
Est custu s’unicu fine
De ogni tassa e deretu,
Chi seguru, e chi quietu
Sutta sa legge si vivat;
De custu fine nos privat
Su Barone pro avarissia,
In sos gastos de Giustissia
Faghet solu economia.
È questo, [infatti], l’unico fine [per cui i governanti impongono] il pagamento di tasse e balzelli: far sì che ognuno possa vivere sicuro e sereno sotto lo scudo della legge; al contrario il barone ci priva di quel bene per eccessiva parsimonia! Però la parsimonia la usa solo per le risorse necessarie all’amministrazione della giustizia!
A conclusione delle considerazioni svolte nella strofa precedente, il poeta richiama qui il fine di ogni società civile e del prelievo fiscale che è il benessere degli amministrati; più specificamente il prelievo fiscale, nelle situazioni qui configurata, dovrebbe assicurare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini attraverso una buona amministrazione della giustizia. I feudatari invece, per mera ingordigia, distorcono dal loro giusto fine le risorse pubbliche. Non solo. Nell’amministrazione, come il poeta dirà nella strofa successiva, il feudatario economizza le spese scegliendo un apparato burocratico ignorante e prono ai suoi voleri.
15.
Su primu chi si presentat
Si nominat Offissiale
Fattat bene, o fattat male
Mentras no chirchet salariu
Procuradore, o Notariu,
o Camereri, o Lacaju,
siat murru, o siat baju,
est bonu pro guvernare.
[Ecco in che modo il barone risparmia nell’amministrazione della giustizia:] Si nomina funzionario il primo venuto: [non importa al barone che questi] amministri [la giustizia] bene o male; ciò che gl’importa è che [l’Ufficiale] non rivendichi uno stipendio; [non importa che il funzionario] sia uomo di leggi o notaio, sia cameriere o lacché, sia grigio o sia baio: tutti sono idonei per avere responsabilità di governo.
Uno dei modi per economizzare nell’amministrazione del feudo consiste nell’assenza di oculatezza nel reclutamento del personale addetto a tutti i rami dell’amministrazione: il feudatario nomina impiegato il primo arrivato, senza badare alle referenze, alla professionalità e alla competenza. Insomma chiunque, si tratti di un laureato in Leggi o di un notaio, di un cameriere o di un lacchè, di un biondo o di un bruno, non fa differenza, è idoneo per svolgere attività di governo. La sola qualità che il funzionare del feudo deve possedere verrà indicata nella strofa successiva.
16.
Bastat chi prestet sa manu
Pro fagher crescher sa renta,
Bastat chi fattat cuntenta
Sa buxia de su Segnore
Chi aggiudet a su fattore
A crobare prontamente,
E si algunu est renitente,
Chi l’iscat executare.
Ciò che basta è che [il funzionario feudale] si dia da fare per accrescere le rendite, per impinguare la borsa del barone; ciò che basta è che sia di valido aiuto all’agente baronale a esigere sollecitamente le tasse, [che sia sollecito], qualora il contribuente sia moroso, nel sottoporne a sequestro giudiziario i beni.
Unica condizione perché il funzionario del feudo sia idoneo per il governo è che sia buon esattore, che conosca bene l’arte di spillare risorse ai vassalli per impinguare la borsa del feudatario. Inoltre non deve chiedere stipendio al feudatario; di conseguenza, ma la conclusione è lasciata dal poeta all’intuizione del lettore o dell’ascoltatore, la burocrazia feudale si sente autorizzata a retribuire il proprio lavoro. Ai balzelli del feudatario, che non devono essere intaccati, si aggiungono quindi quelli destinati a compensare anche il lavoro della sua burocrazia disonesta e famelica.
Si noti la particolare aderenza dei primi quattro versi al linguaggio dei popolani, in particolare quel ‘far contenta la borsa del signore’.
17.
A bortas de Podatariu
Guvernat su Capellanu
Sas Biddas cun una manu;
cun s’altera sa dispenza;
Feudataïriu pensa
Chi sos vasallos non tenes,
solu pro crescher sos benes
solu pro los iscorzare.
Talvolta [capita in qualche feudo dell’isola] che funga da amministratore dei beni feudali un sacerdote: in questo modo con una mano [costui] governa [spiritualmente] i villaggi, con l’altra invece governa la dispensa [cioè i suoi personali e materiali interessi]. Feudatario, rifletti! I vassalli non li hai solo per accrescere il tuo patrimonio, non li hai solo per scorticarli!
La prima parte della strofa 17 conclude l’argomento sulle modalità di reclutamento della burocrazia feudale segnalando che, in qualche caso, il ruolo di podatario è affidato ad un religioso, circostanza che al poeta appare scandalosa e forse anche sacrilega data la difficoltà di conciliare in una stessa persona il governo spirituale con quello temporale. In effetti l’utilizzazione di religiosi non in cura d’anime nel governo del feudo era allora consuetudine abbastanza diffusa: un caso esemplare, coevo agli avvenimenti del triennio rivoluzionario sardo, fu quello del canonico Antonio Spano Azara, di Tempio, podatario generale del marchesato di Orani a nome del titolare, il duca di Hijar, residente in Spagna. Il significato generale della prima parte della strofa è dunque chiaro. È invece piuttosto anodino il significato dei vv. 3-4: che cosa significa che il cappellano-podatario – facciamo riferimento alla traduzione annessa ad un’edizione recente dell’inno – “governa … i villaggi con una mano e con l’altra la dispensa”? (M. Pira, Il meglio della grande poesia in lingua sarda, cit., p. 139). Che cosa ha inteso indicare il poeta con la metafora della “dispensa”? Trattandosi di un religioso nel quale convivono due ruoli di per sé inconciliabili, un’interpretazione possibile dei due versi è che con una mano il “cappellano” governa la comunità spirituale (sas Biddas) e con l’altra la “dispensa”, indicando estensivamente con questo termine, che propriamente significa ‘spesa’ o anche ‘luogo dove si depositano le provviste alimentari’, gli interessi privati e materiali. Ma potrebbe anche interpretarsi nel senso che il ‘cappellano’ con una mano governa la comunità civile (sas Biddas) e con l’altra il potere spirituale, interpretando il termine “dispensa” nel senso di privilegio ecclesiastico o missione religiosa, che comporta la generosa distribuzione non solo dei beni celesti, ma anche di beni materiali: nel qual caso il sost. dispensa avrebbe un senso spiccatamente allusivo, un doppio senso fortemente ironico, per non dire sarcastico. Comunque si debba interpretare, è chiaro che il poeta, nell’evocare questa singolare figura, ha inteso sottolineare l’esistenza di una innaturale commistione dello spirituale col temporale, con allusione alla avidità di certo clero, interessato più ai beni materiali che a quelli spirituali.
La seconda parte della strofa risponde invece, nell’economia del discorso, sia alla funzione di trarre una morale dal tema dell’esosità fiscale dei feudatari, attraverso l’ammonimento, espresso con efficace realismo, che i vassalli non servono solo per ‘scorticarli’ vivi con balzelli di ogni genere, sia alla funzione di introdurre l’argomento delle strofe successive, in cui il poeta si diffonde nel delineare una plastica rappresentazione contrastiva della vita grama, stentata, al limite della sopportazione del vassallo, e di quella cinica, gaudente e frivola del feudatario.
18.
Su patrimoniu, sa vida
Pro defender su villanu
Cun sas armas in sa manu
Cheret ch’istet notte, e die:
Già ch’hat a esser gasìe
Proite tantu tributu?
Si no sinde hat haer frutu
Est locura su pagare.
L’abitante delle comunità rurali per difendere il patrimonio e la sua stessa vita, è costretto a stare giorno e notte con le armi alla mano: ma se le cose stanno così, a che pro [pagare] tanti balzelli? Se non è possibile averne un giovamento è pazzia il pagare.
19.
Si su Barone no faghet
S’obligacione sua,
Vassallu, de parte tua
A nudda ses obligadu
Sos deretos chi hat crobadu
In tantos annos pasados
Sunu dinaris furados
E ti los devet torrare.
Se il barone non fa ciò a cui è obbligato, per parte tua, o vassallo, sei esentato da qualunque obbligo [di contribuzione] e i diritti feudali che [il barone] ha estorto in tanti anni trascorsi sono denari rubati e te li deve restituire.
Come si è accennato sopra, inizia con la strofa 18 la rappresentazione di scene di vita e di situazioni adatte a rendere vivo il contrasto tra l’esistenza del vassallo e quella del feudatario. La prima immagine che il poeta evoca nella strofa 18, coerentemente con i concetti espressi precedentemente, per cui la cattiva amministrazione delle risorse pubbliche non favorisce la sicurezza dei cittadini, è quella di una società rurale sempre all’erta, con le armi in mano, sicuramente non solo in senso metaforico, per difendere i beni e la persona. In questo accenno alla difesa privata, alla quale sono costretti i vassalli in assenza del potere pubblico che assicuri l’amministrazione della giustizia, si può ravvisare un’indiretta allusione ad un’antica piaga sociale della Sardegna, particolarmente presente anche nel Settecento: il banditismo. Il poeta, che è un uomo di legge e un rappresentante dei ceti sociali emergenti, nel constatarne l’esistenza e il pregiudizio che esso arreca allo sviluppo dell’isola, ne denuncia con chiarezza la causa: la colpevole incuria e l’assenza del potere pubblico.
Nella seconda parte della strofa 18 e in quella successiva, seguono tre considerazioni di carattere etico-politico, che costituiscono altrettante parole d’ordine della battaglia ‘legale’ per il riscatto dei feudi da parte delle ‘ville’, efficacemente espressi nel capo IV dell’Achille della sarda liberazione sulla Schiavitù feudistica, cui si è fatto cenno sopra, e che furono accolte nei cosiddetti “strumenti d’unione”, che prevedevano l’eversione del sistema feudale attraverso il mezzo ‘legale’ del pagamento di un equo indennizzo ai feudatari.
La prima considerazione si riferisce al fine delle contribuzioni fiscali. Se la condizione del vassallo, osserva il poeta, è quella di una cronica insicurezza personale e patrimoniale, a che cosa serve assoggettarsi ad una fiscalità tanto esosa? Quando le risorse pubbliche realizzate con tanto sacrificio dai contribuenti non servono per assicurare condizioni di vita civili, pagare tali balzelli è pazzia. Ne consegue la concreta regola di azione del rifiuto al pagamento di essi.
La seconda considerazione interessa l’origine e il fine della società. Riprendendo un concetto espresso in altra parte dell’inno, il poeta ricorda che all’origine della società sta un contratto tra governanti e governati, nel caso specifico tra feudatari e vassalli. Ora, il contratto impone obblighi reciproci. Quando uno dei contraenti contravviene al patto, esso non esiste più né di fatto né di diritto. Poiché questa è la situazione instauratasi tra feudatari e vassalli; poiché i feudatari non adempiono colpevolmente agli obblighi cui sono tenuti, il vassallo si deve ritenere sciolto dal vincolo politico e civile che lo legava ai feudatari. La ribellione contro l’autorità è così giustificata.
La terza considerazione riguarda le conseguenze per l’inadempienza agli obblighi, di cui si sono resi colpevoli i feudatari. I tributi esatti e non impiegati per il giusto fine – argomenta il poeta nella seconda parte della strofa 19 – devono considerarsi rubati e i feudatari li devono restituire: il mal tolto dev’essere reso. Il poeta non si sofferma sulle modalità di questa restituzione, come non fa mai alcun cenno alle ribellioni collettive delle popolazioni rurali e agli assalti ai palazzi baronali, non infrequenti nel triennio, effettuati proprio per recuperare in qualche modo il mal tolto. Se il poeta non fosse uomo di legge e magistrato, probabilmente non avrebbe mancato di far riferimento a tali episodi di giusta ira popolare. Egli si limita in questa parte dell’inno ad argomentare lucidamente sui principi. È però chiaro che questi versi, se non incitano apertamente all’azione violenta, sicuramente la giustificano. Le argomentazioni e l’esemplificazione dell’iniquità del sistema feudale proprie di questa parte sono una remota preparazione all’esplosione d’ira e all’incitamento ad abbattere i tiranni con cui si chiude l’inno.
20.
Sas rentas servini solu
Po mantenner cicisbeas,
Pro carozzas, e livreas
Pro inutiles servicios,
Pro alimentare vicios,
Pro giogare à sa bassetta,
E pro poder sa braghetta
Fora de domo isfogare:
[Al barone] le rendite servono solo per mantenere le amanti, per [avere] carrozze e servitù, per servizi inutili, per alimentare i vizi, per praticare il gioco d’azzardo, per poter sfogare la voglia di puttaneggiare fuori dal focolare domestico.
21.
Pro poder tenner piatos
Bindighi e vinti in sa mesa
Pro chi potat sa Marchesa
Sempre andare in portantina
S’iscarpa istrinta mischina,
La faghet andare a topu
Sas pedras punghene tropu,
E no podet caminare.
[Le rendite servono solo] perché la signora marchesa possa imbandire la sua tavola con quindici o venti pietanze, perché possa sempre essere trasportata in portantina: le scarpe strette, poverina, la fanno zoppicare, le pietre [dell’acciottolato] pungono troppo e non può camminare!
20-21 – Inizia con le strofe 20-21 un’efficace e plastica rappresentazione della vita frivola della nobiltà sarda del Settecento, cui farà da pendant, con efficace contrappunto, la vita di stenti della popolazione rurale. Questa rappresentazione, che richiama alcuni celebri episodi del poema Il Giorno di Giuseppe Parini, si concluderà con la strofa 27. Come dalle strofe del poema pariniano, così da quelle del poeta sardo, ha scritto Raffa Garzia, “balza viva, disegnata con poche linee, anzi per la brevità del verso qua e là scolpita, tutta la nobiltà dell’isola, e fa nascere nel lettore il desiderio di conoscere più addentro i costumi di quel tempo, che il Manno [recte Mannu] fa rivivere per un’ora: quella vita curiosa, effimera e strana che è il Settecento” (Il canto d’una rivoluzione, cit., p. 65). Proprio quest’effimero rappresenta lo status-symbol della frivola società sarda dell’epoca, che s’intravvede nella rappresentazione di questa strofa, non diversa da quella del resto d’Europa: l’oziosa galanteria dei cicisbei, l’ostentazione del lusso delle carrozze e delle tavole riccamente imbandite, la lubricità dei vizi, lo sperpero dei giochi d’azzardo, e infine la comica altezzosità della marchesa che, per evitare il calpestio dell’acciottolato, costringe robuste braccia di servi a sostenerla in portantina. Il quadro descritto riguarda, ovviamente, il tenore di vita che la feudalità conduce nella città, che assurge a simbolo di centro del potere, del divertimento, del vizio. Un artifizio letterario per sottolineare il contrasto con l’immagine che nella strofa successiva il poeta ci dà di ciò che la città rappresenta per il vassallo.
22.
Pro una littera sola
Su Vassallu poverinu
Faghet dies de caminu
A pè, e senza esser pagadu;
Mesu iscurzu, e ispozadu
Espostu a dogni inclemenzia
Eppuru tenet passienzia,
Eppuru devet cagliare.
[Al contrario] il vassallo, poveraccio, [per raggiungere la città] fa giornate di strada a piedi, e senza avere rendita alcuna, mezzo scalzo e mezzo svestito, esposto a tutte le intemperie: e ciononostante deve avere pazienza, deve starsene zitto.
Anche in questo caso la strofa non è di facile interpretazione. A che cosa intende riferirsi il poeta quando evoca l’immagine di un povero viandante che, esposto a tutte le intemperie, deve fare giorni di strada? Per andare dove? Per quale scopo? Secondo la nostra interpretazione, il punto di riferimento per comprendere il significato di questa strofa sono le due precedenti. Abbiamo detto che l’ambiente descritto in esse è quello cittadino, che per il nobile è luogo di svago, di lusso, di vizio. Per il vassallo la città è, al contrario, il luogo del potere, dove egli è talvolta costretto a recarsi per una convocazione o ingiunzione (una littera sola) proveniente dall’autorità giudiziaria o dai rappresentanti del governo viceregio. A quest’ingiunzione – può trattarsi semplicemente di una citazione come teste in un processo, che però al vassallo toglie giornate di lavoro che non gli vengono in alcun modo ripagate - non può rifiutarsi di ottemperare. Alla città il povero vassallo deve recarsi scalzo, sbrindellato, senza alcun mezzo di trasporto, al di fuori delle proprie gambe, che possa alleviargli la fatica del viaggio; al contrario del nobile il quale, anche solo per andare in città dalla casa al teatro, dispone di carrozze, di portantine, di servi, ecc. Nonostante ciò, il vassallo deve soffrire in silenzio e con pazienza: qualunque gesto di disobbedienza o di ribellione comporterebbe sanzioni e malversazioni ulteriori.
È da notare che nell’edizione del Tyndale è omessa la strofa 23, alla quale seguono le strofe 28-31 della edizione originale; le strofe 24-27 sono inserite dopo queste. Ne risulta così stravolta la sequenza logica degli argomenti che, come si è visto, non sempre sono di chiara interpretazione. Anche il Boullier, che si rifa al testo del Tyndale, salta la strofa 23
23.
Ecco comente s’impleat
De su poveru su suore
Comente eternu Segnore
Sufrides tale ingiustissia!
Bois divina giustissia
Remediade a tales cosas;
Bois de sas ispinas rosas
Solu podides bogare.
Ecco come viene investito il sudore del povero! Com’è possibile, eterno Iddio, che possiate sopportare una tale ingiustizia? Voi, che siete la Giustizia divina, dovete porre rimedio a tali cose, solo Voi potete ricavare rose dalle spine!
Dopo le immagini forti sul regime di vita delle due classi sociali protagoniste dell’inno, dopo le riflessioni filosofiche e i ragionamenti giuridici, sgorga fiduciosa, ma nello stesso tempo risentita e sgomenta, la preghiera a Dio: poiché dagli uomini sembra non intravvedersi soluzione ai mali della società, c’è solo da confidare nella Provvidenza divina; Dio solo, che sicuramente guarda con severità l’umiliazione e le ingiustizie cui è sottoposto il povero, vi saprà porre rimedio. Si noti, dopo l’interrogazione sgomenta del vv. 3-4, la delicatezza e la forza di quel sentimento di rassegnazione e insieme di fiducia espresso nei vv. 7-8: solo la fede in Dio è capace di trasformare le spine in rose. Espressione di una fede semplice e forte di cui il popolo è capace. Si vedano anche le strofe 30 e 44.
24.
O poveros de sas Biddas
Trabagliade trabagliade
Pro mantenner in Cittade
Tantos caddos de istalla,
A bois lassan sa palla,
Issos ragoglin su ranu,
E pensan sero e manzanu
Solamente a ingrassare.
Lavorate, lavorate, o poveri dei paesi, per mantenere in città tanti cavalli stalloni! A voi lasciano la paglia mentre essi s’impossessano del grano e mattina e sera pensano solo a ingrassare.
Questa strofa, insieme alla prima e alla quarantaseiesima, è tra le più belle e più note dell’inno: ira e sarcasmo, disperazione e coraggio, denuncia e incitamento, disprezzo e coscienza dei propri diritti, realismo e lirismo si fondono in un quadro che offre una sintesi compiuta dei temi e del messaggio presenti nell’inno.
25.
Su Segnor Feudatariu
A sas undighi si pesa
Dae su lettu a sa mesa,
Dae sa mesa a su giogu,
E pustis pro disaogu
Andat à cicisbeare,
Crompende a iscurigare
Teatru, ballu, allegria.
Il signor feudatario si leva alle undici, dal letto a tavola, e dalla tavola al gioco e poi, per distrarsi, va a corteggiare qualche donna; [infine], come arriva la sera, teatro, ballo e baldoria.
Dopo la pausa di riflessione e di preghiera della strofa precedente, il poeta riprende la narrazione con scene di vita contrapposte del nobile e del villano, descrivendo la giornata di entrambi. Il feudatario si alza tardi al mattino, va dal letto alla tavola, dalla tavola al gioco, e poi, per svago, passa ai corteggiamenti delle dame, e infine, col giungere della notte, teatro, balli, divertimenti. Molto diversa, come dirà nella strofa successiva, la giornata del povero vassallo. Si noti, en passant, un aspetto di carattere stilistico: in precedenza il poeta aveva dedicato due strofe (nn. 20-21) per descrivere la condizione del ceto feudale ed una sola (la n. 22) per descrivere quella del vassallo; qui i rapporti sono rovesciati: la strofa 25 è dedicata al feudatario, mentre le due successive, n. 26-27, sono dedicate al vassallo.
26.
Cantu diferentemente
Su Vassallu passat s’ora!
Innanti de s’aurora
Già est bessidu in campagna,
Bentu, e nie in sa montagna
In su paris sole ardente;
O poveritu comente
Lu podet agguantare?
Come trascorre diversamente il suo tempo il vassallo! Esce per [lavorare] nella campagna già prima dell’alba; che egli trovi vento o neve [quando va a lavorare] nella montagna, o trovi il sole ardente [quando lavora] nella pianura [è sempre lo stesso]! Oh poveretto! Come fa a resistere?
27.
Cun su zappu e cun s’aradu
Peleat tota sa die,
A ora de mesu die
Si cibat de solu pane;
Mezus paschidu est su cane
De su Barone in Cittade
Si est de cudda calidade
Ch’in falda solen portare.
Ogni santo giorno s’arrabatta con la zappa e con l’aratro; a metà giornata si ciba solo di un tozzo di pane! È meglio pasciuto in città il cane del barone, specialmente se è di quella razza che [le donne della nobiltà] sono solite portare in grembo.
Quanto è diversa, al contrario di quella del signore, la giornata del vassallo! Ancora non è spuntata l’alba ed egli, per guadagnare tempo e per poter sfruttare interamente la luce, è già in cammino per recarsi al lavoro, qualunque siano le condizioni del tempo. Su massaiu o massazu, che è la tipica figura del lavoratore dei villaggi della Sardegna, un po’ contadino e un po’ pastore per poter assicurare alla famiglia una dignitosa sussistenza, non si cura né delle bufere invernali, quando deve lavorare nel salto, la zona in altura del territorio, né della calura ardente, quando è impegnato per la mietitura nella vidazzone. Per una migliore comprensione della strofa è opportuno ricordare che in genere i luoghi di lavoro (la montagna o salto e la pianura o vidazzone) distano dai villaggi a volte anche diverse ore di cammino: di qui l’abitudine di percorrere almeno parte della distanza prima che spunti l’alba, in modo da sfruttare al massimo le ore di luce. Eccolo, dunque, il nostro massaio, combattere affannosamente ogni giorno per guadagnarsi un tozzo di pane, il solo alimento – ma è detto in modo enfatico per rendere più efficace l’immagine successiva – che riesce a strappare alla terra. Il cane del barone in città mangia sicuramente meglio del contadino, soprattutto se si tratta di quelle specie piccole e vezzose che dame e damigelle sogliono tenere e coccolare in grembo. Queste tre strofe riecheggiano alcune parti del Giorno del Parini, in particolare: il risveglio del giovin signore contrapposto al risveglio della natura e dei comuni mortali, di cui ai vv. 33-157 del Mattino e il celebre episodio della “vergine cuccia”, narrato nei vv. 510-556 del Mezzogiorno. Con la doverosa avvertenza che si tratta di echi abbastanza lontani, che non autorizzano paragoni forzati e tantomeno contiguità e apparentamenti d’ispirazione e di stile, che non sembrano onestamente proponibili.
III
Gli avvenimenti sardi del 1793-1795 (strofe 28-30).
Le tre strofe costituiscono un rapido riassunto delle vicende triennio, che il poeta introduce al termine della delineazione degli aspetti politici, economici, giuridici e sociali del sistema feudale, in difesa dei patrioti sardi più zelanti e più convinti della necessità delle riforme nella Sardegna di fine Settecento.
28.
Timende chi si reformen
Disordines tantu mannos,
Cun manizos, et ingannos
Sas Cortes han impedidu;
E isperder han querfidu
Sos Patricios pius zelantes
Nende chi sun petulantes
E contra sa Monarchia.
[I feudatari] per timore che si ponesse mano a riformare scompigli così colossali hanno fatto di tutto per impedire la convocazione del Parlamento e hanno deciso di perseguitare fino a disperderli quei membri dello Stamento militare più convinti [della necessità delle riforme], accusandoli di essere arroganti e nemici della monarchia [accusandoli cioè di essere dei repubblicani incalliti, seguaci dei repubblicani francesi regicidi].
29.
Ai cuddos ch’in favore
De sa patria han peroradu
Chi s’ispada hana bogadu
Pro sa causa comune
O a su tuyu sa fune
Cherian ponner meschinos
O comente Giacobinos
Los cherian massacrare.
[Così] coloro che hanno perorato la causa per il riscatto della [comune] patria [di Sardegna], che [durante la tentata invasione dei francesi nel 1793] hanno [valorosamente] combattuto per la causa di tutti i Sardi, volevano condannarli all’impiccagione o massacrarli come Giacobini [così come avvenne in Francia con la reazione di Termidoro, quando, a partire dal luglio 1794, ghigliottinato Robespierre e i principali capi giacobini, questi furono messi fuori legge e le bande della “gioventù dorata” promossero, con il consenso della Convenzione, il “terrore bianco”, una spietata caccia all’uomo che colpì con assassinii e massacri i seguaci del governo rivoluzionario giacobino].
30.
Pero su Chelu hat deffesu
Sos bonos visibilmente,
Aterradu hat su potente,
Ei s’umile exaltadu;
Deus chi s’est declaradu
Pro custa Patria nostra,
De ogni insidia bostra
Isse nos hat a salvare.
Però il Cielo ha difeso visibilmente i buoni [e zelanti patrioti], ha atterrato i potenti [cioè il marchese della Planargia e Girolamo Pitzolo assassinati nel luglio 1795, ma anche i Francesi sconfitti nel 1793] e ha esaltato gli umili [cioè i buoni patrioti e tutti i Sardi che lottano per le riforme e per affermare i diritti del popolo sardo]. Il Signore Iddio, che ha preso partito per questa nostra patria, ci salverà anche da ogni vostra macchinazione.
Nelle strofe 28-30 il riferimento alle vicende storiche del triennio rivoluzionario sardo – vicende, non si dimentichi, ancora in atto quando il Mannu scrive l’inno – si fanno precise e circostanziate.
Il poeta, dopo avere a lungo delineato i caratteri e la storia remota del sistema feudale, sente l’esigenza di spiegare al lettore le cause prossime di quella vasta sollevazione popolare contro i feudatari che si sta svolgendo nell’autunno del 1795 quando il Mannu, con ogni verosimiglianza, si accinge a comporre l’inno. Con un’improvvisa variazione di tema egli riassume così, nelle strofe 28-30, con brevi ma inequivocabili cenni, le tappe salienti che hanno scandito le vicende del movimento patriottico sardo a partire dal 1793. In questo modo egli salda in un tutt’uno il triennio, mostrando come sarebbe errato considerare la sollevazione antifeudale come l’unico aspetto importante della lotta dei Sardi contro il malgoverno piemontese. Il punto di partenza è ancora, coerentemente con quanto ha sin qui narrato, la cancrena politica e sociale del sistema feudale: è per evitate la riforma di esso e il risanamento dei gravi disordini politici e sociali che esso determina che gli oppositori delle riforme hanno anzitutto compiuto ogni sforzo, anche ricorrendo ai maneggi sotterranei e agli inganni, per impedire la convocazione delle Corti. È stato questo il primo è più grave affronto inferto dai nemici delle riforme al movimento dei veri patrioti (sos Patricios pius zelantes), e per essi all’intera nazione sarda. La convocazione delle Corti, il solo organo dello Stato legittimato a rappresentare al sovrano le riforme necessarie per avviare la rinascita della Sardegna, era non a caso la prima e fondamentale delle ‘cinque domande’ elaborate dai tre Stamenti solennemente riuniti a Cagliari nella primavera del 1793. Fu proprio dai dibattiti stamentari che la nazione sarda trasse motivo e slancio per rivendicare l’autonomia del Regno e la compartecipazione alla gestione dello Stato, secondo il dettato costituzionale per cui, essendo la forma statuale del Regno sardo una “monarchia mista”, l’esercizio della sovranità appartiene a pari titolo al sovrano e agli organi rappresentativi, le Cortes appunto, che i nuovi dominatori piemontesi non avevano mai convocato dal 1720 in poi. Ma le riunioni stamentarie del 1793 non erano il Parlamento legittimamente convocato: le ‘cinque domande’ erano, per così dire, un’anticipazione della necessità, condivisa da tutta la nazione, di un dibattito che esaminasse in profondità le cause del malessere della Sardegna e ciò era possibile solo nel Parlamento solennemente convocato dal sovrano. Nella convocazione delle Corti il movimento patriottico aveva riposto tutte le sue speranze. La realizzazione di questo voto della nazione fu invece impedita dalle macchinazioni del Pitzolo e del Planargia dopo che, nel febbraio 1795, il sovrano aveva ufficialmente annunciato, attraverso il ministro per gli Affari di Sardegna conte Pietro Avogadro di Quaregna, la prossima convocazione del Parlamento. I maneggi dei due alti funzionari avevano portato il governo di Torino, alcuni mesi dopo e con la connivenza del nuovo ministro Galli della Loggia, al ritiro di quella promessa e al tentativo di far fuori i “patrioti più zelanti”, sia con vere e proprie liste di proscrizione sia attraverso la loro delegittimazione, consistente quest’ultima nell’accusa, infamante per i patrioti, di essere dei giacobini eversori dello Stato e del reggimento monarchico. Le trame del Pitzolo e del Planargia furono finalmente scoperte e ciò segnò la loro fine: furono infatti assassinati rispettivamente il 6 e il 22 luglio 1795.
Tutto ciò, grazie al Cielo, dice il poeta nella strofa 30, è ormai acqua passata. Ora è chiaro, dirà il poeta nella strofa 31, con la quale inizia la lunga analisi dei rapporti tra i sardi e i dominatori piemontesi, il motivo per cui i feudatari felloni stanno di nuovo cementando l’alleanza con quei Piemontesi che l’ira del popolo cagliaritano aveva cacciato dall’isola il 28 aprile 1794: vogliono con tutti i mezzi impedire le riforme e innescare, come vedremo, la guerra civile tra il Capo settentrionale e quello meridionale.
IV
La cacciata dei Piemontesi del 28 aprile 1794 e le sue motivazioni (strofe 31-44).
Il poeta delinea il difficile rapporto del colonialismo piemontese con la Sardegna e ne denuncia e i soprusi e le connivenze con il ceto feudale sardo.
31.
Perfidu Feudatariu!
Pro interesse privadu,
protettore declaradu
ses de su Piemontesu:
cun isse ti fisti intesu
cun meda facilidade,
isse papàda in Citade,
e tue in Bidda a porfia.
Perfido feudatario! Solo per difendere [i tuoi] interessi egoisitici ti sei dichiarato protettore manifesto dei Piemontesi: con i Piemontesi avevi contratto con grande facilità, [considerata la coincidenza degli interessi], uno stretto e reciproco patto: a gara lui arraffava ricchezze in città e tu nei villaggi infeudati.
32.
Fit pro sos Piemontesos
Sa Sardigna una cucagna
Su chi in sas Indias s’Ispagna
Issos incontràn inoghe:
Nos alzaiat sa boghe
Finza unu Camereri,
O plebeu, o Cavaglieri
Si deviat umiliare.
La Sardegna rappresentava per i Piemontesi il paese di cuccagna, essi trovavano qui ciò che [i conquistadores] spagnoli trovavano nelle Indie. Ci dava sulla voce perfino un cameriere; il sardo, fosse popolano o nobile, doveva sottomettersi.
33.
Issos dae custa terra
Ch’hana bogadu migliones
Benian senza calzones
E sinde andàn galonados;
Mai ch’eseren intrados
Chi hana postu su fogu;
Malaitu cuddu logu,
Chi criat tale zenia.
Costoro da questa terra hanno drenato milioni; venivano qui in mutande e se ne ripartivano con i galloni. Maledetto il giorno in cui sono entrati [nella nostra isola] perché ne hanno fatto terra bruciata; maledetto la terra che ha dato i natali a simile genìa.
Inizia con la strofa 31 il lungo excursus contro i Piemontesi che si concluderà con la strofa 43. Come nella descrizione del sistema feudale, anche in questa parte ogni strofa ci offre, con metafore efficaci e con immagini popolaresche vive e dense di colore, un quadro mosso e articolato del rapporto tra Sardi e Piemontesi, attraverso una chiara separazione di responsabilità in questo rapporto tra il comportamento dei feudatari, stretti alleati dei Piemontesi nello sfruttamento delle risorse dell’isola, e il popolo sardo, vittima dell’ingordigia e della malversazione di entrambi. Non sfuggirà in questa parte come la condivisione dei sentimenti antipiemontesi da parte del poeta faccia un tutt’uno con quello del popolo sardo. Per indicare questa stretta condivisione il poeta ricorre ad un accorgimento stilistico degno di nota: il popolo sardo è spesso indicato semplicemente con la particella pronominale atona nos, ‘ci, con funzione di compl. di termine: v. 32.5 (nos alzaiat sa oghe, ‘ci dava sulla voce’), v. 35.1 (sos disculos nos mandàna, ‘ci mandavano persone poco raccomandabili’), vv. 39.5/6 (de sos Archivos furadu/nos hana sas mezus pezzas, ‘ci hanno rubato dagli archivi i documenti più importanti’), vv. 40.1/2 (De custu flagellu in parte/Deus nos hat liberadu, ‘Dio ci ha liberato in parte da questo flagello’).
Per individuare il periodo del triennio in cui il poeta scrive la sua invettiva contro i Piemontesi e contro i feudatari sono di particolare importanza i vv. 1-4 di questa strofa. Si è già messo in rilievo l’uso del pres. ind. del verbo essere nel v. 4. Qual è il preciso momento in cui il feudatario ‘perfido’, per mero interesse privato – e quindi non per difendere ciò che nel v. 29.4 ha chiamato sa causa comune, ‘il bene pubblico’ – si è dichiarato protettore, ossia si è schierato completamente dalla parte dei Piemontesi? E perchè il feudatario viene definito con epiteti tanto oltraggiosi come perfidu, ‘perfido’, indignu, ‘indegno’ (vv. 40.1 e 40.6), ‘sfacciato’ (v. 41.1 preigas iscaradamente, ‘predichi sfacciatamente’), traitore, ‘traditore’ (v. 41.4), ‘fellone’ (v. 4.6 bendes sa patria tua, ‘vendi la tua patria’), maneggione occulto e diffamatore (v.v. 42.7/8 procuras … a cua sos Sardos increditare, ‘ti adoperi per screditare di nascosto i Sardi’), traitore e ispia, ‘traditore e spia’ (v. 43.8)?
L’inquadramento storicamente corretto di questa parte dell’inno suggerisce di rifarsi brevemente alle vicende immediatamente successive all’assassinio di Pitzolo e del Planargia nel luglio 1795, cui alludevano le strofe 28-30. Dopo l’eccidio dei due alti funzionari, i feudatari sassaresi, con la speciosa motivazione che Cagliari e il viceré Vivalda fossero ormai in balia del partito ‘giacobino’, interessarono alla difesa dell’isola il viceré inglese della Corsica lord Elliot e fecero pervenire a Torino una rappresentanza nella quale chiedevano che l’amministrazione del Capo settentrionale venisse staccata da quella del Capo meridionale e che venisse inviato in Sardegna un forte contingente di truppe ‘estere’ per sedare le sollevazioni antifeudali del Logudoro. Il governo di Torino, con regio biglietto del 31 agosto 1795, avallò in parte la richiesta dei feudatari sassaresi, autorizzando il governatore di Sassari a non prestare obbedienza alle disposizioni viceregie quando queste venissero giudicate pregiudizievoli agli interessi del Capo settentrionale. Questa autorizzazione, alquanto equivoca, spinse la Reale Governazione di Sassari sulla via della secessione. Infatti a metà ottobre il governatore Santucciu si ritenne legittimato a emanare un pregone – subito sconfessato dal viceré Vivalda – in cui ordinava alle popolazioni del Capo settentrionale di non prestare obbedienza agli ordini del viceré. Ne seguì un braccio di forza tra le due autorità, che comportò l’invio di tre commissari ad acta viceregi nel Logudoro per verificare villaggio per villaggio la fedeltà delle autorità locali al legittimo governo di Cagliari. Questa fase dello scontro politico tra Sassari e Cagliari, su cui si innestò il movimento antifeudale delle popolazioni del Logudoro, culminò con la conquista di Sassari da parte di un esercito contadino alla fine di dicembre 1795 e con la fuga dei feudatari dalla citta turritana.
I termini con cui il poeta si esprime nei primi quattro versi della strofa 31, dove il verbo usato al pres. ind. esprime la contemporaneità dell’azione rispetto a chi scrive, non sembra riferirsi al fatto, di grande rilevanza, della capitolazione di Sassari alla fine di dicembre, ma ai temi e alle polemiche del periodo immediatamente precedente. La ‘perfidia’ del feudatario – espressioni e concetti analoghi si ritrovano nelle rappresentanze degli Stamenti e negli atti di governo del viceré dei mesi tra agosto e novembre 1795 – è dovuta anzitutto alla falsità delle affermazioni contenute nelle rappresentanze sassaresi inviate a Torino tra luglio e settembre 1795: in esse i patrioti cagliaritani venivano accusati di aver preso contatti con la Repubblica francese per invitarla ad una nuova spedizione contro la Sardegna e di aver trasformato gli Stamenti in un covo di giacobini. Secondo il poeta, i feudatari sassaresi camuffano dietro queste false accuse la loro volontà di non concedere nulla alle istanze portate avanti dal partito patriottico cagliaritano, che era al potere dall’aprile 1794. Queste istanze erano condivise dai feudatari del Capo di Cagliari che, nella prima metà di agosto, d’accordo col viceré, avevano emanato una circolare in cui si dichiaravano disposti a discutere, davanti al governo viceregio ed agli Stamenti, i diritti controversi di cui le ‘ville’ facenti parte dei rispettivi feudi si ritenessero illegittimamente gravate. Per avviare questo contenzioso feudatari e viceré invitavano i Consigli comunitativi a inviare a Cagliari un loro rappresentante dotato di regolari poteri per dirimere le controversie tra feudatari e vassalli. Diversi di questi rappresentanti delle ‘ville’ si recarono effettivamente a Cagliari a partire dall’ottobre 1795.
Ecco, dunque, in che cosa consiste la ‘perfidia’ del feudatario: l’ottusa opposizione a qualunque proposta di soluzione del contenzioso dei balzelli feudali – ecco il ‘privato interesse’ -, gabellandola come difesa dell’istituto monarchico e come lotta contro l’anarchia e contro i ‘giacobini’ – ecco il presunto pubblico interesse -. Per portare avanti questo progetto i feudatari sassaresi si fanno ora paladini dei Piemontesi, invocandone il ritorno, dopo che erano stati cacciati via dall’isola nell’aprile del 1794 con il consenso unanime dei Sardi. La cacciata dei Piemontesi aveva dato luogo ad una sorta di governo autonomo in quanto, nonostante la presenza del viceré piemontese Vivalda, tutte le cariche a partire dall’aprile 1794 erano attribuite ai Sardi. Questa situazione durava ancora tra l’estate e l’autunno 1795, quando si innescò il contenzioso feudale ad opera delle popolazioni rurali. Poiché gli ultimi esiti di quel governo autonomo non rispondono più agli interessi particolari dei feudatari sassaresi, essi hanno effettuato un clamoroso voltafaccia: si sono nuovamente alleati con le forze retrive del governo piemontese, in particolare con il ministro per gli Affari di Sardegna conte Galli della Loggia, che ne accoglie le istanze separatiste e la richiesta di invio di truppe ‘estere’ – durante il governo autonomo si era andata lentamente costituendo una forza armata ‘nazionale’ – per contrastare e vanificare la “rivoluzione sarda”.
È partendo da questa situazione del presente che, subito dopo, usando la stessa tecnica narrativa della prima parte dell’inno dedicata al feudalesimo, il poeta volge lo sguardo indietro nel tempo per narrare la storia della dominazione piemontese in Sardegna iniziata nel 1720. Ciò spiega la repentina variazione del tempo verbale nel v. 31.5, in cui la narrazione, volgendosi ai primordi della dominazione piemontese, viene introdotta da un pass. rem. La prima verità che il poeta scopre attraverso questo primo sguardo sulla storia del Settecento sardo è che l’alleanza tra l’inaffidabile feudalità sarda e la famelica burocrazia piemontese ha radici remote. Tra l’una e l’altra era nata da subito una ‘facile intesa’: i feudatari – molti dei quali risiedevano in Spagna – avrebbero drenato risorse dalle popolazioni rurali, i funzionari piemontesi dalle sette città regie.
34.
Issos inoghe incontràna
Vantaggiosos hymeneos
Pro issos fin sos impleos,
Pro issos fin sos honores,
Sas dignidades mazores
De Cheia, Toga, e Ispada
E a su Sardu restàda
Una fune a s’impicare.
Costoro qui in Sardegna contraevano matrimoni d’interesse, essi erano i soli beneficiari degli impieghi e delle onorificenze, delle più prestigiose dignità ecclesiastiche, civili e militari: al Sardo restava solo una corda per impiccarsi!
I primi due versi si riferiscono, in particolare, agli apparentamenti di piemontesi con nobildonne della feudalità sarda. È possibile che il poeta, col riferimento ai matrimoni d’interesse, volesse riferirsi ad uno in particolare, che in quegli anni era sulla bocca di tutti: il matrimonio del conte Pietro Graneri con la vedova del duca di San Pietro, personaggi che ebbero tanta parte nel fallimento della missione stamentaria delle “Cinque domande” a Torino. Al ministro Graneri e all’intrigante consorte i patrioti sardi attribuivano la responsabilità del fallimento di quella missione. Ma la parte più importane e significativa della strofa, i vv. 3-6, fa riferimento in modo inequivocabile alla terza ‘domanda’, che era stata formulata come protesta contro la sistematica occupazione di tutti gli impieghi da parte dei Piemontesi, con la conseguenza che ai giovani sardi che ne avevano capacità e titolo, era interdetta ogni possibilità di carriera nella pubblica amministrazione: da ciò la cruda e realistica conclusione che al Sardo altro non restava che mettersi una fune al collo. La terza domanda chiedeva “la nomina de’ Nazionali alle quattro mitre riservate nell’ultimo Parlamento del 1698, come pure, a riserva della carica di Viceré, agli impieghi secolari privativamente”.
35.
Sos disculos nos mandàna
Pro castigu e corressione
Cun paga, e cun penzione
Cun impleu, e cun patente:
In Moscovia tale Zente
Si mandat a sa Siberia
Pro chi morgiat de miseria,
Pero no pro governare.
[Il governo piemontese] per castigare o per tentare di redimere persone poco raccomandabili, le spediva in Sardegna e per giunta titolari di stipendio e di pensione, patentati per occupare i posti della pubblica amministrazione: [perfino] in Russia gente di tal fatta viene spedita in Siberia perché, [come merita], finisca i suoi giorni in miseria, non certo con incarichi di governo!
Con il termine disculu/os nei pregoni viceregi dell’epoca venivano indicati i cosiddetti “soggetti discoli’ o “maioli”, ossia giovani “riottosi, scapestrati, indocili” (si veda ad es. il regio editto 30 agosto 1808 in E. Scano, Storia della educazione e degli istituti educativi in Sardegna, Cagliari 1894, p. 79). Il termine è registrato dallo Spano (VSI); per il Wagner il sost. ‘discolo’ corrisponde in sardo a discipulu/dissibulu, ‘discepolo’, usato in log. anche nel senso di ‘ragazzo irrequieto, discolo’, che è una correzione di discipulu “per ingerenza appunto di discolo” (DES, I, 473, s. v. disîpulu). Nel testo si registra un ampliamento di significato: da discolo, come ‘irrequieto, irregolare’ si passa a ‘ultimo, perché indisciplinato e irregolare, tra quelli adatti a far qualcosa’, quindi il ‘peggiore’ di una categoria, in questo caso quella dei funzionari regi. Da notare l’assimilazione in peius che l’autore fa tra il regime autocratico della Russia (“in Moscovia”) dell’epoca della zarina Caterina II (1762-1796), giudicato maggiormente intonato ad un senso di giustizia sociale di quanto non lo fosse l’assolutismo sabaudo degli anni del governo di Vittorio Amedeo III. Se il governo zarista mandava i “discoli”, i funzionari infedeli o colpevoli di reato, che in ogni caso avevano dato pessima prova come funzionari statali, nella desolata Siberia, il governo sabaudo li mandava, secondo il sentimento della popolazione sarda, nell’esilio dorato della Sardegna, dove si arricchivano e contraevano perfino “vantaggiosos hymeneos” (v. strofa precedente), ossia matrimoni altolocati, anche se si trattava, secondo la colorita terminologia plebea dell’interlocutore contadino, di un nettacessi, come dirà nella strofa 41 (“mancari siat bassèri”), di persona, cioè, di infimo rango sia sotto il profilo sociale che morale.
36.
Intantu in s’Isula nostra
Numerosa Gioventude
De talentu, e de virtude
Ozïosa la lassàna;
E s’algunu nd’impleàna
Chircàna su pïus tontu
Proghi lis torràda a contu
Cun Zente zega tratare.
36. Intanto essi [Piemontesi] permettevano che nella nostra isola un gran numero di giovani pieno di talento e di virtù si consumasse nell’ozio; e se per caso decidevano di dare a qualcuno un impiego, lo sceglievano tra i più ottusi, perché ad essi conviene avere a che fare con persone prive d’intelligenza.
37.
Si in impleos subalternos
Algunu Sardu avanzàda,
In regalos no bastàda
Su mesu de su salariu:
Mandare fit necessariu
Caddos de casta a Turinu
E bonas cascias de binu
Cannonau, e malvasia.
37. Se, per caso, per meriti suoi, qualche sardo riusciva a conquistarsi un piccolo impiego, non gli bastava in regali [al suo superiore] la metà dello stipendio: era costretto a spedire a Torino cavalli di razza, casse di vini pregiati, di cannonau e di malvasia.
36-37- Le due strofe ampliano e specificano il tema degli impieghi da attribuire ai soli sardi, richiesta presente da lungo tempo nelle petizioni degli Stamenti ai sovrani già nel periodo della dominazione spagnola e particolarmente dibattuto durante il triennio rivoluzionario sardo. La conseguenza più grave dell’occupazione a tappeto di tutti gli impieghi della pubblica amministrazione da parte dei Piemontesi è stata quella di di condannare i nostri giovani capaci e intelligenti ad un ozio frustrante. La gioventù piena di talenti e di virtù evocata in questo brano dal poeta è soprattutto la cosiddetta “gioventù studiosa”, cioè quella generazione di giovani, tra cui il Mannu, che aveva frequentato le due Università di Cagliari e di Sassari riformate dal Bogino nel 1764-65, che aveva titoli professionali e culturali legittimi per entrare nei ranghi della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista non si può dire che il riformismo piemontese degli anni del Bogino sia stato conseguente: non si favorisce la nascita di un ceto intellettualmente e professionalmente idoneo a ricoprire i posti della burocrazia senza offrire loro un’adeguata prospettiva d’impiego. Questo concetto di una gioventù colta e illuminata non utilizzata viene ulteriormente posta in risalto dai versi 36.5-8, dominati dall’ironica figura del giovane sardo ottuso (tontu), privo del lume dell’intelligenza (zente zega), il genere di suddito sardo che i Piemontesi destinano, molto di rado in verità, a ricoprire qualche impiego di basso profilo. I Piemontesi, suggerisce il poeta, hanno tutta la convenienza a promuovere qualche sardo di tal genere perché non in grado di comprendere il danno che i suoi protettori arrecano all’isola. Ma anche quando l’impiego era frutto di merito proprio, continua il poeta nella strofa 37, i Piemontesi pretendevano di essere considerati benefattori, ma per nulla disinteressati! Anche all’impiegato sardo che si era conquistato un piccolo impiego per virtù propria non bastava la metà dello stipendio per sdebitarsi col suo invadente protettore: doveva far pervenire nella capitale subalpina cavalli di razza e costose casse di vini pregiati dell’isola, come il cannonau e la malvasia. Il tempo verbale è sempre l’imperfetto perché, come si è già rilevato, l’azione è sempre rivolta al passato: i Piemontesi non sono presenti nell’isola perché espulsi nel 1794.
38.
Tirare a su Pïemonte
Sa plata nostra, ei s’oro
Est de su Governu insoro
Maxima fundamentale;
Su Regnu andet bene o male
No lis importat niente,
Antis cren incunveniente
Lassarelu prosperare.
38. Imperativo fondamentale del loro Governo è drenare in Piemonte l’oro e l’argento nostro; ad essi non interessa un fico secco che il Regno sardo sia governato bene o sia governato male; ritengono anzi di non trarre profitto dal curarne la rinascita.
La politica del governo piemontese, denuncia il poeta, si è sempre caratterizzata come un colonialismo di rapina; la regola fondamentale è stata sempre quella di succhiare le ricchezze dell’isola e trasferirle in terraferma. Ciò perché ai Piemontesi non interessa affatto che la Sardegna sia ben governata; ritengono sia contraria ai loro interessi la sua prosperità. Si tratta di considerazioni dettate più dalla virulenza della polemica del periodo in cui l’inno fu composto, che non da una serena valutazione del dato storico; esse suonano alquanto ingiuste, soprattutto se riferite al quindicennio di governo del ministro Gian Lorenzo Bogino (1759-1773), in cui venne portata avanti una importante politica di riforme. È anche da considerare, tuttavia, che durante il regno di Vittorio Amedeo III, in particolare a partire dagli anni Ottanta, il malgoverno e le malversazioni dei funzionari piemontesi raggiunsero limiti insopportabili. A titolo di esempio si può ricordare la vicenda del governatore di Sassari Allì Maccarani nel 1780.
39.
S’Isula hat arruinadu
Custa razza de bastardos
Sos privilegios Sardos
Issos nos hana leadu;
De sos Archivos furadu
Nos hana sas mezzus pezzas
E che iscrituras bezzas
Las hana fattas bruxiare.
39. Questa razza di bastardi ha rovinato la nostra isola, ci ha sottratto i nostri ‘privilegi [cioè i nostri diritti o libertates], ha rubato dai nostri archivi i documenti più importanti e li ha fatti bruciare come cartaccia vecchia [priva di importanza].
La denuncia del malgoverno dei Piemontesi termina con un apprezzamento pesantissimo al loro indirizzo: questa razza di bastardi ha rovinato la Sardegna. Subito dopo, nei vv. 3-8, il poeta richiama l’argomento della ‘seconda domanda’, inquadrandola in un’altra accusa che la pubblica opinione rivolgeva contro i Piemontesi: il furto e l’abbruciamento delle carte dei pubblici archivi che contenevano i ‘privilegi’ o libertates dei ceti, dei corpi rappresentativi e delle città regie – in genere si trattava dei Capitoli di Corte annessi agli atti dei diversi Parlamenti celebrati nei secoli precedenti e di estratti contenenti i ‘privilegi’; per quanto riguarda le città essi venivano conservati di norma negli archivi dell’amministrazione civica. La seconda domanda prevedeva “l’osservanza, e confermazione de’ Privilegi, e Leggi fondamentali del Regno”.
Al fine di ovviare a questo presunto furto di documenti d’archivio, un gruppo di patrioti, tra cui l’archivista Nicolò Angioy e gli avvocati Vincenzo Cabras e Salvatore Cadeddu, tra la primavera e l’estate 1793 fecero pazienti ricerche nell’archivio civico di Cagliari e fecero pervenire quanti ‘privilegi’ riuscirono a trovare alla delegazione stamentaria, che si trovava già a Torino, affinché potesse avvalersi dei documenti come pezze giustificative nel Ragionamento giustificativo delle cinque domande, che fu presentato a Vittorio Amedeo III nel mese di dicembre.
40.
Dae custu flagellu in parte
Deus nos hat liberadu
Sos Sardos ch’hana bogadu
Custu dannosu inimigu;
E tue li ses amigu
O Sardu Barone indignu?
E tue ses in s’impignu
De ndelu fagher torrare?
40. Iddio ci ha liberato, in parte, da questo flagello; i Sardi hanno cacciato via [dopo la giornata del 28 aprile 1794] questo nemico pernicioso! Tu, invece, indegno barone sardo, gli sei amico; non solo, ma ti stai dando da fare per farlo ritornare!
Le strofe 40-43 affrontano ancora il tema dei Piemontesi, ma con lo scopo di denunciare il tradimento dei baroni, che facendo ogni sforzo per farli ritornare in Sardegna, vanificano quel moto corale della loro cacciata, questa fu causata dalla sollevazione cagliaritana del 28 aprile 1794, quando, con l’aiuto del Cielo, i Sardi hanno rispedito i Piemontesi alle loro case. I Sardi, osserva il poeta, hanno cacciato “in parte” i Piemontesi: il Mannu è un fautore radicale dell’autonomia dei Sardi e di un programma patriottico che si può riassumere nel motto: La Sardegna ai Sardi. Probabilmente, secondo il suo modo di vedere, la cacciata dei Piemontesi non avrebbe dovuto risparmiare neppure gli alti prelati, che invece non furono coinvolti nello “scommiato” e la stessa presenza del viceré doveva apparirgli come dannosa e inopportuna. Per inquadrare meglio il radicalismo del Mannu, si badi al linguaggio virulento e apocalittico con cui fa riferimento ai Piemontesi, che sono definiti ‘flagello’, quasi fossero una delle bibliche piaghe d’Egitto, e “nemici dannosi”. Questi accenti forti preparano l’apostrofe dei quattro versi successivi, che introducono, nella finzione letteraria, l’ultimo contraddittorio ad personam tra il poeta e il feudatario, che continua anche nelle strofe 41-43. “Se i Piemontesi sono il nemico dannoso che tutti i Sardi conoscono, incalza il poeta, com’è che tu, barone, gli sei amico? Com’è che ti impegni a farlo ritornare?”. Dove si osserverà, sul piano stilistico, l’efficacia delle antitesi su cui è giocata l’apostrofe: ‘nemico/amico’, ‘cacciar via/ritornare’. Come s’è detto sopra, questa situazione, nuova rispetto alla coralità del moto antipiemontese, è da riferire a un momento storico determinato nell’ambito delle vicende del triennio: l’estate- autunno 1795, quando la feudalità sassarese tentò, con parziale successo, di favorire la secessione del Capo settentrionale.
41.
Pro custu iscaradamente
Preïgas pro Pïemonte:
Falsu chi portas in fronte
Sa marca de traitore;
Fizas tuas tantu onore
Faghen a su Furisteri,
Mancari siat Basseri
Bastat chi Sardu no siat.
41. È per questo che vai perorando in modo sfacciato la causa del Piemonte. Falso! Tu porti stampato sulla fronte il marchio del traditore! Intanto le tue figlie accolgono il forestiero con tutti gli onori! Anche se è un nettacessi, basta che non sia sardo!
“è dunque per far ritornare i Piemontesi, continua il poeta nel suo immaginario contraddittorio con il feudatario, che sfacciatamente vai predicando in loro favore, che vai dicendo che fu gravissimo errore averli cacciati dall’isola”. Secondo i baroni sassaresi, infatti, che accusavano gli Stamenti e il movimento patriottico di essere in contatto con la Francia rivoluzionaria, l’unico modo per ricondurre la Sardegna all’obbedienza, era quello di inviarvi un forte contingente di truppa ‘estera’. “Falso! – accusa il Mannu – tu porti stampato in fronte il marchio di traditore”. Questa accusa, che nei dispacci dei baroni sassaresi al sovrano veniva rivolta ai patrioti cagliaritani per i presunti contatti con la Francia, è una chiara ritorsione dell’accusa stessa al mittente.
Segue quindi, dopo l’enunciazione della premessa, secondo uno stile narrativo che abbiamo visto essere caratteristico del poeta, la descrizione di alcuni episodi emblematici, la cui funzione è quella di esemplificare, con immagini appropriate per l’immaginario semplice e realistico delle popolazioni rurali, che sono i veri destinatari dell’inno, il concetto espresso nella premessa: i baroni sono da sempre gli alleati dei Piemontesi. Il primo episodio emblematico è riferito alle figlie dei feudatari. È tramite le damigelle di nobile lignaggio che il “dannoso nemico” viene fatto rientrare gradatamente in Sardegna. “Le tue figlie, incalza il poeta, accolgono con tutta deferenza lo straniero (su Furisteri), fosse anche un nettacessi! L’importante è che non sia sardo!”. Si ricorderà che questo strumento di integrazione dei Sardi con i Piemontesi, avversato dal Mannu, cioè il matrimonio tra donne sarde e uomini piemontesi, ma non viceversa, è stato richiamato anche nei vv. 34.1/2: Issos inoghe incontràna / vantaggiosos hymeneos. Mentre quella strofa si chiudeva con una considerazione tragica (a su Sardu restàda / una fune a s’impiccare), qui prevale il disprezzo scurrile, particolarmente efficace per alimentare l’odio popolare e il sarcasmo. Un registro espressivo su cui il poeta insiste nelle due strofe successive, in cui la narrazione è inframmezzata da allusioni scurrili.
42.
S’a casu andas in Turinu,
Inie basare des
A su Ministru sos pes,
E a atter, “su già m’intendes”
Pro ottenner su chi pretendes
Bendes sa patria tua,
E procuras forzi a cua
Sos Sardos iscreditare.
42. Se per caso vai a Torino, lì sei costretto a baciare i piedi al ministro, e a qualche altro il … tu mi capisci! Per ottenere ciò che chiedi, tu vendi la tua patria, e probabilmente di nascosto ti adoperi a gettare discredito sui Sardi.
“Eppure, continua il poeta nel suo dialogo diretto col feudatario, neppure per te è onorevole e dignitoso essere amico dei Piemontesi. Prova ne sia il fatto che, quando ti capita di recarti a Torino per chiedere qualche vantaggio personale, sei costretto a baciare i piedi al ministro e … il deretano ad altri. Non solo, ma per ottenere quel che chiedi, sei costretto a vendere la patria e a diffamare i tuoi compatrioti”. Non è escluso che con il riferimento alla fellonia (bendes sa patria tua) e alla diffamazione (sos Sardos iscreditare), il Mannu intendesse riferirsi a due episodi accaduti nel luglio 1795, che stanno all’origine della svolta secessionista dei feudatari sassaresi. Dopo l’uccisione del Pitzolo il partito oltranzista di Sassari aveva mandato in Corsica il canonico Antonio Sotgiu per consegnare una richiesta di intervento in Sardegna al viceré inglese lord Elliot: il Sotgiu riparò subito dopo a Torino. Qualche tempo dopo riparò a Torino anche il giudice della Reale Governazione Andrea Flores, che era stato il vero artefice della missione in Corsica, motivata dall’accusa rivolta al partito patriottico cagliaritano di aver chiesto alla Francia rivoluzionaria una nuova spedizione in Sardegna per instaurarvi la repubblica.
43.
Sa buxia lassas inie
Ed in premiu nde torras
Una rughita in pittorras
Una giae in su traseri;
Pro fagher su quarteri
Sa domo has arruinadu
E titulu has acquistadu
De traitore e ispia.
43. Lì [a Torino] ci lasci la borsa e come premio ne riporti una [piccola onorificenza costituita da] crocetta o una chiave nel deretano. Per andare a acquartierarti a Corte [in qualità di gentiluomo di camera] hai rovinato la tua famiglia, e per soprappiù hai acquistato il titolo di traditore e di spia.
Il poeta conclude il suo immaginario colloquio col feudatario con un quadro di grande efficacia, denso di immagini insieme tragiche e comiche, di sommo disprezzo e di irridente sarcasmo. “Lì a Torino tu, o feudatario, lasci i tuoi averi per acquistare con moneta sonante onorificenze avvilenti, e ritorni qui con le buffe insegne di quelle: una crocetta che esibisci nel petto e una chiavetta che penzola nel deretano! Per arruolarti come cortigiano, hai mandato in rovina la tua famiglia e il vero titolo che ti sei acquistato è quello di fellone e di spia!”. Due qualifiche che costituiscono la sentenza finale e inequivocabile con cui il patriota Mannu volge definitivamente le spalle al feudatario per svolgere la perorazione finale, rivolto ora all’interlocutore vero dell’inno: i vassalli del Logudoro.
Atto V
Perorazione e incitazione finale (strofe 44-48).
Con le quattro strofe finali il poeta conclude la sua lunga e complessa rievocazione dei mali della società sarda, incitando le popolazioni infeudate (sos poveros de sas biddas) del Logudoro a non demordere dalla lotta e a dare la spallata decisiva al sistema feudale: tra la fine del 1795 e i primi del 1796 l’obiettivo dell’abolizione del feudalesimo sembrava ai patrioti veramente alla portata di mano.
44.
Su Chelu non lassat sempre
Sa malissia triunfende
Su Mundu istat reformende
Sas cosas chi andana male,
Su sistema Feudale
No podet durare meda
Custu bender pro moneda
Sos Populos det cessare.
44. Per fortuna il Cielo non permette che la malvagità trionfi sempre, e il mondo attuale, [l’uomo guidato dalla filosofia dei lumi] sta impegnandosi nella riforma delle storture [della società]; per questo il sistema feudale non può ancora avere lunga vita; questo mercimonio di popoli deve finire una volta per tutte.
45.
S’homine chi s’impostura
Haiat già degradadu
Paret ch’a s’antigu gradu
Alzare cherfat de nou,
Paret chi su rangu sou,
Pretendat s’Humanidade.
Sardos mios ischidade,
E sighide custa ghia.
L’uomo, che è stato degradato dall’impostura, pare che voglia di nuovo sollevarsi all’antica dignità, pare che l’umanità rivendichi il suo rango. Sardi miei, svegliatevi, è questa la strada che dovete seguire!
44-45. La perorazione finale, contenuta nelle quattro strofe finali, si articola in due parti ben definite. Le strofe 44-45 sono dedicate dal poeta alla riaffermazione della fede, a un tempo religiosa e civile, nella vittoria finale della rivoluzione, del moto antifeudale e della filosofia dei lumi che ne sorregge l’azione; le strofe 46-47 sono invece un appassionato e robusto incitamento alla lotta finale e decisiva contro il dispotismo e contro gli abusi dei feudatari.
I primi quattro versi della strofa 44 ribadiscono, ancora una volta, la fiducia nella Provvidenza: Iddio non lascia che il male trionfi all’infinito, prova ne sia il fatto che su Mundu, ‘il Mondo’, che qui è sinonimo de s’Humanidade, ‘l’Umanità’, di cui il poeta dirà nella strofa successiva, va lentamente ma visibilmente riformando storture e ingiustizie, tra cui il sistema feudale. È ragionevole e necessario, così come è accaduto in altre parti dell’Europa, che questa assurdità di vendere i popoli per denaro finisca una volta per tutte anche in Sardegna.
La strofa 45 è quella che meglio di tutte esprime la filosofia civile del Mannu, che è a pieno titolo un progressista del suo tempo, un illuminista. Al centro del cammino della Storia – è questa la profonda convinzione del poeta - sta l’Umanità, sta l’Uomo, sta il progresso della Ragione. Le imposture dell’oscurantismo, dell’ignoranza, avevano degradato l’uomo, l’avevano reso schiavo, lo avevano trasformato in merce di scambio. Ora, nel secolo della Ragione, nel secolo del progresso e delle riforme, l’Uomo sembra deciso a riconquistare integralmente la sua antica dignità (antigu gradu); sembra che l’Umanità intera, ogni persona umana, non i soli membri dei ceti privilegiati come è stato per secoli, esiga in modo perentorio il rispetto delle sue prerogative, dei suoi diritti (su rangu sou). Sardi, svegliatevi dal lungo letargo! È questa la guida, è questa la filosofia che dovete seguire!
46.
Custa Populos est s’ora
De estirpare sos abusos
A terra sos malos usos,
A terra su despotismu
Gherra gherra a su egoismu,
E gherra a sos oppressores
Custos tiranos minores
Est precisu umiliare.
46. Popoli, è giunta l’ora di estirpare gli abusi! A terra le cattive consuetudini, a terra il dispotismo! Guerra, guerra all’egoismo e guerra agli oppressori! Dovete umiliare [i feudatari,] questi piccoli tiranni!
47.
Sino calqui die a mossu
Bonde segades su didu,
Como chi est su filu ordidu
A bois toccat su tesser,
Mizzi chi poi det esser
Tardu s’arrepentimentu
Cando si tenet su bentu
Est precisu bentulare.
Se non lo fate un giorno vi staccherete le dita a morsi! Ora che la trama è già ordita, spetta a voi tessere! Badate che poi sarà tardivo il pentimento. Quando [sull’aia] tira il vento favorevole, allora si deve separare il grano dalla pula.
L’inno si chiude con due magnifiche strofe, dense di passione e di saggezza.
Nella strofa 45, dopo aver indicato i mezzi indispensabili per ottenere la vittoria sui ‘piccoli tiranni”, mezzi rappresentati dalla fiducia nella Provvidenza e nelle armi della Ragione, il poeta indirizza alle popolazioni rurali l’incitazione finale: è questa l’ora per estirpare gli abusi, per mandare in frantumi le cattive usanze, per abbattere il dispotismo! Guerra senza quartiere agli interessi particolari e guerra agli oppressori! Dobbiano umiliare questi tirannelli da strapazzo! Con l’avvertenza che l’incitazione alla lotta non interessa solo gli abusi e le prepotenze baronali, ma tutti gli abusi e le prepotenze presenti nella società di allora, quelli perpetrati dai funzionari piemontesi fino alla loro cacciata dall’isola come quelli ancora perpetrati dai feudatari. Né può essere diversamente, a pena di impoverire il significato storico dell’inno. Sebbene l’inno abbia come bersaglio principale i feudatari, gli abusi e le ingiustizie che vi sono a lungo puntigliosamente denunciati sono dei baroni come sono stati dei Piemontesi, di tirannelli locali come di alti funzionari, di facinorosi ufficiali baronali come di oscuri impiegatucci dell’amministrazione regia. Anche se i Piemontesi sono “in parte” sconfitti – si ricordi il monito del poeta del v. 40.1: solo “in parte” sconfitti, con il rischio molto concreto, grazie alla fellonia dei feudatari, che i Piemontesi ritornino presto in Sardegna. L’inno contro i feudatari è, a pieno titolo, l’inno della rivoluzione sarda: della lotta vittoriosa contro i francesi, della piattaforma politica della Nazione espressa nelle ‘cinque domande’, della cacciata dei Piemontesi, della lotta contro i feudatari. Nell’inno il moto delle campagne si salda intimamente col moto delle città, con le rivendicazioni della Nazione sarda.
La strofa conclusiva, col suo linguaggio semplice e realistico, è un concentrato di saggezza e di intensa ispirazione lirica, dove, alla metafora realistica del mangiarsi le dita per la rabbia, qualora non venga sfruttata l’occasione propizia, si accompagna la saggezza antica dei due proverbi che evocano, con intensità espressiva, due momenti importanti della vita rurale, in cui sono coinvolte le donne come gli uomini delle popolazioni delle campagne sarde: la paziente orditura del filo per la tessitura e il raccolto. Ora che l’orditura è pronta, sono le popolazioni (sos Populos) che debbono tessere la tela. Ora che il vento è propizio, occorre approfittarne per concludere sull’aia il lungo e faticoso lavoro del raccolto.
PARTE QUARTA
La traduzione poetica di Sebastiano Satta (1896)
Sebastiano Satta, ovvero quando, a volte anche i Grandi prendono abbagli …
Un’attenta lettura della versione italiana di Sebastiano Satta del canto della “Sarda Rivoluzione” evidenzia una serie di licenze poetiche e di autentici travisamenti del significato di alcuni passi. Si vedano, ad esempio, i vv. 3 e 8 della strofa 4, in cui il Mannu le due espressioni di sapore chiaramente illuministico (“finalmente despertadu” e “bona filosofia”) vengono resi rispettivamente con “al fin disperaro” e “a tutte buone cose”, laddove l’Autore ha voluto marcare la derivazione della sua “filosofia” dal “risveglio” (dallo spagnolo “despertar”) della coscienza civile in un secolo tutto permeato, negli uomini più avvertiti, dal programma di una necessità di riforme profonde nella società e nelle istituzioni del secolo; oppure la strofa 6, in cui il riferimento a “sas populassiones”, che altro non sono che le “ville” dell’ambiente rurale, volte al singolare (“la popolazione”) svisa il senso proprio della strofa, ulteriormente illanguidito dalla traduzione con l’aggettivo “gramo”, riferito sia al “genere umano” sia alla “schiatta sarda”, rispetto al più incisivo e forte aggettivo “poveru”, che è insieme una precisa qualifica morale riferita all’umanità e alla reale miseria delle popolazioni sarde sotto il giogo feudale; o ancora nella strofa 7, la resa dell’espressione “zega antichidade [sic!]” con quella del tutto erronea “empia antichità”, laddove il Mannu, come si evince dal senso del seguito della strofa, intendeva dire che quel passato era “buio” nel senso che non era rischiarato dalla filosofia dei Lumi, , che il nuovo secolo (“sa presente edade”), rischiarato dalla ragione intende modificare e riformare in vista di una società più equa e più giusta. Per non parlare poi delle numerose mende presenti nella trascrizione, frutto probabilmente di una tradizione prevalentemente orale con cui fu tramandato l’inno, poco rispettosa del dettato originario e recepita dal poeta nuorese: prima fra tutte il titolo con cui fu tramandato, con quel vocabolo “patriottu” non facente parte, come si è già osservato, del lessico logudorese del Mannu.
Non procediamo oltre nella segnalazione di altre imperfezioni e travisamenti nella traduzione e nella trascrizione presenti nella versione poetica Satta, anche perché il lettore potrà agevolmente coglierle da sé. Alla traduzione poetica effettuata da Sebastiano Satta vanno tuttavia riconosciuti almeno due innegabili meriti. In primo luogo essa, che resta a tutt’oggi, l’unica versione poetica in italiano effettuata da un poeta di sicura e duratura fama, costituì un importante veicolo di diffusione dell’inno in ambito letterario nazionale. In secondo luogo, in un contesto intellettuale sardo del tutto incline all’assorbimento della lingua e della cultura italiane, il testo offerto dal Satta contribuì in modo decisivo al dare diritto di cittadinanza all’inno del Mannu anche fra le classi “colte” della società sarda, facendone la bandiera del rivendicazionismo e delle lotte politiche e sociali dei progressisti della nostra Isola.
[da stampare su due colonne: a sinistra il testo in sardo, a destra la versione in italiano]
Francesco Ignazio Mannu
Su patriottu sardu a sos feudatarios
(Versione poetica in italiano di Sebastiano Satta, da La poesia della rivoluzione angioina, in “La Nuova Sardegna”, 1 marzo 1896, n. 59)
1. Procurade e moderare,
Barones, sa tirannia,
Chi si no, pro vida mia,
Torrades a pe’ in terra!
Declarada est già sa gherra
Contra de sa prepotenzia,
E cominzat sa passienzia
ln su pobulu a mancare.
1. Cercate di frenare,
Baroni, la tirannia,
Se no, per vita mia,
Ruzzolerete a terra!
Dichiarata è la guerra
Contro la prepotenza
E sta la pazienza
Nel popolo per mancare
2. Mirade ch’est azzendende
Contra de ois su fogu;
Mirade chi non est giogu
Chi sa cosa andat a veras;
Mirade chi sas aeras
Minettana temporale;
Zente cunsizzada male,
Iscultade sa ‘oghe mia.
2. Badate! contro voi
Sta divampando il foco;
Tutto ciò non è gioco
Ma gli è fatto ben vero;
Pensate che il ciel nero
Minaccia temporale;
Gente spinta a far male,
Senti la voce mia
3. No apprettedas s ‘isprone
A su poveru ronzinu,
Si no in mesu caminu
S’arrempellat appuradu;
Mizzi ch’es tantu cansadu
E non ‘nde podet piusu;
Finalmente a fundu in susu
S’imbastu ‘nd ‘hat a bettare.
3. Non date più di sprone
Nel povero ronzino,
O in mezzo del cammino
Si fermerà impuntito;
Gli è tanto stremenzito
Da non poterne più,
E finalmente giù
Dovrà il basto gittare
4. Su pobulu chi in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente despertadu
S’abbizzat ch ‘est in cadena,
Ch’istat suffrende sa pena
De s’indolenzia antiga:
Feudu, legge inimiga
A bona filosofia!
4. Il popolo, da profondo
Letargo ottenebrato,
Sente al fin disperato,
Sente le sue catene,
Sa di patir le pene
Dell’indolenza antica.
Feudo, legge nemica
A tutte buone cose!
5. Che ch’esseret una inza,
Una tanca, unu cunzadu,
Sas biddas hana donadu
De regalu o a bendissione;
Comente unu cumone
De bestias berveghinas
Sos homines et feminas
Han bendidu cun sa cria.
5. Quasi fosse una vigna
O un oliveto o un chiuso,
Borghi e terre han profuso…
Li han dati e barattati
Come branchi malnati
Di capi pecorini;
Gli uomini ed i bambini
Venduto han colle spose.
6. Pro pagas mizzas de liras,
Et tale olta pro niente,
Isclavas eternamente
Tantas pobulassiones,
E migliares de persones
Servint a unu tirannu.
Poveru genere humanu,
Povera sarda zenia!
6. Per poche lire han reso,
E talvolta per niente,
Schiava eternamente
La popolazione;
Mille e mille persone
Curvansi ad un sovrano.
Gramo genere umano,
Grama sarda genia!
7. Deghe o doighi familias
S’han partidu sa Sardigna,
De una menera indigna
Si ‘nde sunt fattas pobiddas;
Divididu s’han sas biddas
In sa zega antichidade,
Però sa presente edade
Lu pensat rimediare.
7. Si hanno poche famiglie
Partito la Sardegna.
In maniera non degna
Furono fatte ancelle
Le nostre terre belle
Nell’empia antichità;
Or questa nostra età
Vuol ciò rimediare
8. Naschet su Sardu soggettu
A milli cumandamentos,
Tributos e pagamentos
Chi faghet a su segnore,
In bestiamen et laore
In dinari e in natura,
E pagat pro sa pastura,
E pagat pro laorare.
8. Nasce il Sardo, soggetto
A rei comandamenti;
Tributi e pagamenti
Deve dare al sovrano
In bestiame ed in grano
In moneta e in natura;
Paga per la pastura,
Paga per seminare.
9. Meda innantis de sos feudos
Esistiana sas biddas,
Et issas fìni pobiddas
De saltos e biddattones.
Comente a bois, Barones,
Sa cosa anzena est passada?
Cuddu chi bos l’hat dada
Non bos la podiat dare.
9. Già, pria che i feudi fossero,
Fiorian i borghi lieti’
Di campi e di vigneti,
Di pigne e di covoni;
Or come a voi, Baroni,
Tutto questo è passato?
Colui che ve l’ha dato
Non vel potea dare.
10. No est mai presumibile
Chi voluntariamente
Hapat sa povera zente
Zedidu a tale derettu;
Su titulu ergo est infettu
De s’infeudassione
E i sas biddas reione
Tenene de l’impugnare
10. Nè alcun potrà presumere
Che volontariamente
Tanta povera gente
Innanzi a voi si prostri;
Questi titoli vostri
San d’infeudazione
Le ville hanno ben ragione
Di volerli impugnare.
11. Sas tassas in su prinzipiu
Esigiazis limitadas,
Dae pustis sunt istadas
Ogni die aumentende,
A misura chi creschende
Sezis andados in fastu,
A misura chi in su gastu
Lassezis s ‘economia.
11. I balzelli che prima
Sembravan men penosi,
Più forti e più dannosi
A noi voi li rendeste
Man mano che cresceste
In lusso ed in pretese,
Scordando tra le spese
La buona economia.
12. Non bos balet allegare
S’antiga possessione
Cun minettas de presone,
Cun gastigos e cun penas,
Cun zippos e cun cadenas
Sos poveros ignorantes
Derettos esorbitantes
Hazis forzadu a pagare
12. Nè vi giova accampare
Possession avita.
Con minacce di vita,
Con castighi e con pene,
Con ceppi e con catene
Dai poveri ignoranti
Imposte esorbitanti
Voi sapeste spillare.
13. A su mancu s ‘impleerent
In mantenner sa giustissia
Castighende sa malissia
De sos malos de su logu,
A su mancu disaogu
Sos bonos poterant tenner,
Poterant andare e benner
Seguros per i sa via.
13. E almeno si spendesse
In prò della Giustizia
Per punir la nequizia
Degli sparsi predoni,
E potessero i buoni
Di salute fruire
Ed andare e venire
Sicuri per la via!
14. Est cussu s’unicu fine
De dogni tassa e derettu,
Chi seguru et chi chiettu
Sutta sa legge si vivat,
De custu fine nos privat
Su barone pro avarissia;
In sos gastos de giustissia
Faghet solu economia
14. A ciò solo servire
Dovrian pesi e diritti,
A guardar da’ delitti
Chi nella legge viva.
Ma di tal ben ci priva
Del Baron l’avarizia
Che in spese di giustizia
Fa solo economia
15. Su primu chi si presentat
Si nominat offissiale,
Fattat bene o fattat male
Bastat non chirchet salariu,
Procuradore o notariu,
O camareri o lacaju,
Siat murru o siat baju,
Est bonu pro guvernare.
15. Chi sa meglio brigare
Vien fatto uffiziale.
Faccia egli bene o male,
Ma non chiegga denaro;
Leguleio o notaro,
Servidore o lacchè
Sia bigio o sia tamè
Nato è per governare
16. Bastat chi prestet sa manu
Pro fagher crescher sa rènta,
Bastat si fetat cuntenta
Sa buscia de su Segnore;
Chi aggiuet a su fattore
A crobare prontamente
Missu o attera zante
Chi l’iscat esecutare
16. Basta che faccia in modo
Di render più opulenta
L’entrata e più contenta
La borsa del signore,
Ed aiuti il fattore
A trovar, prestamente
O messo od altra gente
Scaltra nel pignorare.
17. A boltas, de podattariu,
Guvernat su cappellanu,
Sas biddas cun una manu
Cun s’attera sa dispensa.
Feudatariu, pensa, pensa
Chi sos vassallos non tenes
Solu pro crescher sos benes,
Solu pro los iscorzare.
17. Talvolta da Barone
Suol fare il cappellano;
Le ville ha in una mano
Nell’altra ha la dispensa.
Feudatario, deh! pensa
Che schiavi non ci tieni
Per accrescerti i beni,
Poterci scorticare.
18. Su patrimoniu, sa vida
Pro difender su villanu
Cun sas armas a sa manu
Cheret ch ‘istet notte e die;
Già ch ‘hat a esser gasie
Proite tantu tributu?
Si non si nd’hat haer fruttu
Est locura su pagare.
18. Tu vuoi che per difenderti
Il povero villano
Vegli con l’arme in mano
L’intera notte e il dì;
Se deve esser così
E se nulla godiamo
Di ciò a te paghiamo,
E’ da stolti il pagare.
19. Si su barone non faghet
S’obbligassione sua,
Vassallu, de parte tua
A nudda ses obbligadu;
Sos derettos ch’hat crobadu
In tantos annos passodos
Sunu dinaris furados
Et ti los devet torrare.
19. E se il Barone gli impegni
Non tien da parte sua,
Villan, per parte tua
A nulla se’ obbligato;
I soldi che succhiato
Ei ti ha negli anni andati,
Son danari rubati
E te li de’ ridare.
20. Sas rèntas servini solu
Pro mantenner cicisbeas,
Pro carrozzas e livreas,
Pro inutiles servissios,
Pro alimentare sos vissios,
Pro giogare a sa bassetta,
E pro poder sa braghetta
Fora de domo isfogare,
20. Giovan solo le rendite
A procacciar brillanti,
Livree, carrozze e amanti,
A creare servizi
Vani, a crescer vizi.
A scacciar la noia
E a poter ogni foia
fuori casa sfogare,
21. Pro poder tenner piattos
Bindighi e vinti in sa mesa,
Pro chi potat sa marchesa
Sempre andare in portantina;
S’iscarpa istrinta mischina,
La faghet andare a toppu,
Sas pedras punghene troppu
E non podet camminare.
21. Ad avere dieci o venti
Portate a mensa ognora,
Per poter la signora:
Cullare in portantina;
La scarpetta (o meschina!)
Le sbuccia il bel piedino,
Lo punge un sassolino
E non può camminare.
22. Pro una littera solu
Su vassallu, poverinu,
Faghet dies de caminu
A pe’, senz ‘esser pagadu,
Mesu iscurzu e ispozzadu
Espostu a dogni inclemenzia;
Eppuru tenet passienzia,
Eppuru devet cagliare.
22. Per portare un messaggio
Il vassallo, tapino!,
Fa giorni di cammino
A piedi, non pagato,
Va scalzo, sbrendolato,
Esposto a ogn’inclemenza
E pur con pazienza
Soffre e non de’ parlare.
23. Ecco comente s ‘impleat
De su poveru su suore!
Comente, Eternu Segnore,
Suffrides tanta ingiustissia?
Bois, Divina Giustissia,
Remediade sas cosas,
Bois, da ispinas, rosas
Solu podides bogare.
23. Così si sparge il vivo
Sangue del nostro cuore!
Or come tu, Signore,
Soffri tanta ingiustizia?
Tu, Divina Giustizia,
Rimedia queste cose,
Tu sol puoi far le rose
Dai tronchi germogliare.
24. Trabagliade trabagliade
O poveros de sas biddas,
Pro mantenner’ in zittade
Tantos caddos de istalla,
A bois lassant sa palla
Issos regoglin’ su ranu,
Et pensant sero e manzanu
Solamente a ingrassare.
24. O miseri villani,
Sfiniti dal lavoro
Per mantener costoro
Come tanti stalloni!
Per lor sono i covoni,
A voi dan la pagliata,
E sbarcan la giornata
Pensando ad ingrassare.
25. Su segnor feudatariu
A sas undighi si pesat.
Dae su lettu a sa mesa,
Dae sa mesa a su giogu.
Et pastis pro disaogu
Andat a cicisbeare;
Giompidu a iscurigare
Teatru, ballu, allegria
25. Sorge tardi dal letto
Il feudatario, e pensa
Tosto a mettersi a mensa,
Va dalla mensa al gioco;
Per poi svagarsi un poco
Si reca a donneare;
Più tardi, all’annottare,
Scene. danze, allegria.
26. Cantu differentemente,
su vassallu passat s’ora!
Innantis de s’aurora
Già est bessidu in campagna;
Bentu o nie in sa muntagna.
In su paris sole ardente.
Oh! poverittu, comente
Lu podet agguantare!
26. Quanto diversamente
Volge al vassallo l’ora!
Già prima dell’aurora
Egli è nella campagna;
Brezze e nevi in montagna,
Al piano sole ardente;
Ahi! come può il paziente
Tal vita tollerare!
27. Cun su zappu e cun s’aradu
Penat tota sa die,
A ora de mesudie
Si zibat de solu pane.
Mezzus paschidu est su cane
De su Barone, in zittade,
S’est de cudda calidade
Chi in falda solent portare.
27. Con la vanga e l’aratro
Geme l’intero giorno;
Biascica a mezzo giorno
Un sol tozzo di pane.
Meglio, assai meglio il cane
Si pasce del signore.
Quel can che a tutte l’ore
Suol dietro a sè portare.
28. Timende chi si reforment
Disordines tantu mannos,
Cun manizzos et ingannos
Sas Cortes han impedidu;
Et isperdere han cherfidu
Sos patrizios pius zelantes,
Nende chi fint petulantes
Et contra sa monarchia.
28. Le Cortes osteggiarono
Con raggiri e soprusi
Perchè codesti abusi
Non dovesser cessare;
Cercaron di fugare
I patriotti migliori
Dicendoli fautori
D’odio alla monarchia.
29. Ai cuddos ch ‘in favore
De sa patria han peroradu,
Chi s ‘ispada hana ogadu
Pro sa causa comune,
O a su tuju sa fune
Cheriant ponner meschinos.
O comente a Giacobinos
Los cheriant massacrare.
29. A chi levò la voce
Per la natia contrada
A chi strasse la spada
Per la causa comune
Volean cinger di fune
Il collo: od i meschini
Siccome Giacobini
Volevan massacrare.
30. Però su chelu hat difesu
Sos bonos visibilmente,
Atterradu bat su potente,
Ei s ‘umile esaltadu,
Deus, chi s ‘est declaradu
Pro custa patria nostra,
De ogn’insidia bostra
Isse nos hat a salvare.
30. Ma il cielo, il ciel i giusti
Guardò veracemente;
Atterrato ha il possente
E ha l’umile esaltato
Iddio s’è dichiarato
Per questa terra nostra,
Ed ogni insidia vostra
Egli dovrà sfatare.
31. Perfidu feudatariu!
Pro interesse privadu
Protettore declaradu
Ses de su piemontesu.
Cun issu ti fist intesu
Cun meda fazilidade:
Isse papada in zittade
E tue in bidda a porfia.
31. Per far tue mire prave,
Feudatario inumano,
Chiaramente la mano
Distendi al Piemontese
E con lui sulle intese
Stai per far le tue voglie
I borghi tu, egli toglie
Le cittadi a pelare.
32. Fit pro sos piemontesos
Sa Sardigna una cucagna;
Che in sas Indias s ‘Ispagna
Issos s ‘incontrant inoghe;
Nos alzaiat sa oghe
Finzas unu camareri,
O plebeu o cavaglieri
Si deviat umiliare…
32. Fu per Piemontese l’isola
Nostra una gran cuccagna;
Come l’Indie la Spagna
Egli ci mette in croce;
Non mai levò la voce
Un vil cameriere,
Che servo o cavaliere
Non si dovean piegare
33. Issos dae custa terra
Ch’hana ogadu migliones,
Beniant senza calzones
E si nd’handaiant gallonados;
Mai ch’esserent istados
Chi ch’hana postu su fogu
Malaittu cuddu logu
Chi criat tale zenìa
33. Essi da questa terra
han tratto milioni.
Giungean senza calzoni
E partian gallonati
Non ci fossero mai stati
Per cacciarci in tal fuoco.
Sia maledetto il loco
Che cresce tal genia.
34.
Issos inoghe incontràna
Vantaggiosos imeneos,
Pro issos fint sos impleos,
Pro issos sint sos onores,
Sas dignidades mazores
De cheia, toga e ispada:
Et a su sardu restada
Una fune a s’impiccare!
34. Essi trovano tra noi
Splendidi maritaggi
A lor gli appannaggi,
A lor tutti gli onori,
Le dignità maggiori
Di stola, spada e toga;
Ed al sardo una soga
Per potersi appiccare.
35. Sos disculos nos mandàna
Pro castigu e curressione,
Cun paga e cun pensione,
Cun impleu e cun patente;
In Moscovia tale zente
Si mandat a sa Siberia
Pro chi morzat de miseria,
Però non pro guvernare
35. Tutti i facinorosi
tra noi per punizione
Mandan, e han pensione
E stipendi e patente;
In Russia una tal gente
La si manda in Siberia
Per crepar di miseria
Ma non per governare.
36. Intantu in s’insula nostra
Numerosa gioventude
De talentu e de virtude
Ozïosa la lassàna:
E si algun ‘nd’impleàna
Chircaiant su pius tontu
Pro chi lis torrat a contu
cun zente zega a trattare.
36.E intanto, intanto lasciano
Qui molti virtuosi
Giovani inoperosi
Che in mezzo all’ozio annegano:
E se alcuno ne impiegano
Lo cercano sciocco a prova,
Però che a loro giova
Coi ciechi aver da fare.
37. Si in impleos subalternos
Algunu sardu avanzàna,
In regalos non bastada
Su mesu de su salariu,
Mandare fit nezessariu
Caddos de casta a Turinu
Et bonas cassas de binu,
Muscadellu e malvasia.
37. Se d’impiegucci al sardo
Talor son liberali,
Questi deve in regali
Spender tutto il salario,
Poichè gli è necessario
Di spedire a Torino
Bei cavalli, buon vino,
Moscato e malvasia.
38. De dare a su piemontesu
Sa prata nostra ei s’oro
Est de su guvernu insoro
Massimu fundamentale,
Su regnu andet bene o male
No lis importat niente,
Antis creen incumbeniente
Lassarelu prosperare.
38. Nel dar al Piemontese
Il nostro oro e l’argento
Sta tutto il fondamento
Della possanza loro.
E che importa a costoro
Che vada male il regno,
Se essi credon non degno
Il farlo prosperare?
39. S’isula hat arruinadu
Custa razza de bastardos;
Sos privilegios sardos
Issos nos hana leadu,
Dae sos archivios furadu
Nos hana sas mezzus pezzas
Et che iscritturas bezzas
Las hana fattas bruiare.
39. Guasto ha l’isola nostra
Quest’orda di bastardi;
I privilegi sardi
Ci ha tolto; degli archivi
Nostri ci ha fatto privi;
Come robaccia, parte
Delle memori carte
Nostre ha fatto bruciare.
40. De custu flagellu, in parte,
Deus nos hat liberadu.
Sos sardos ch’hana ogadu
Custu dannosu inimigu,
E tue li ses amigu,
O sardu barone indignu,
E tue ses in s’impignu
De ‘nde lu fagher torrare?
40. Ma (volle Iddio) siam quasi
Da tal danno risorti.
I Sardi sono insorti
Contro l’empio nemico,
E tu, Baron, da amico
Anche adesso lo tratti!
E indegno ti arrabatti
Per farlo ritornare?
41. Pro custu, iscaradamente,
Preigas pro su Piemonte,
Falzu chi portas in fronte
Su marcu de traitore;
Fizzas tuas tant’honore
Faghent a su furisteri,
Mancari siat basseri
Bastat chi sardu no siat.
41. Perciò tu a viso aperto
Decanti il Piemonte,
Vile, lo stigma in fronte
Del traditor tu porte!
Le tue figlie la corte
Fanno al primo venuto,
Valga men d’uno sputo
Pur che sardo non sia.
42. S’accas ‘andas a Turinu
Inie basare dès
A su minustru sos pes
E a atter su… già m ‘intendes;
Pro ottenner su chi pretendes
Bendes sa patria tua,
E procuras forsis a cua
Sos sardos iscreditare.
42. Se ti rechi a Torino,
Non appena lo vedi
Baci al ministro i piedi,
Baci agli altri il…m’intendi;
Purchè ciò che pretendi
Ti diano per danaro,
Vendi la patria e caro
Ti è dei sardi sparlare.
43. Sa buscia lassas inie,
Et in premiu ‘nde torras
Una rughitta in pettorra
Una giae in su traseri;
Pro fagher su quarteri
Sa domo has arruinodu,
E titolu has acchistadu
De traitore e ispia.
43. Là ti mungon la borsa,
Ma in cambio fai ritorno
Di croci e stemmi adorno.
Perchè venisse eretto
Il quartiere, il tuo tetto,
Il tuo tetto atterrasti,
E nome meritasti
Di traditore e spia.
44. Su chelu non faghet sempre
Sa malissia triunfare,
Su mundu det reformare
Sas cosas ch ‘andana male,
Su sistema feudale
Non podet durare meda?
Custu bender pro moneda
Sos pobulos det sensare.
44. Ma il cielo non vuol che sempre
Trionfi la tristizia
E deve la giustizia
Infrangere ogni male.
La potestà feudale
Già tocco ha la sua meta;
Il vender per moneta
Le plebi de’ cessare.
45. S’homine chi s ‘impostura
Haiat già degradadu
Paret chi a s’antigu gradu
Alzare cherfat de nou;
Paret chi su rangu sou
Pretendat s’humanidade;
Sardos mios, ischidade
E sighide custa ghia.
45. L’uomo cui molto urgeva
Secolar tenebrore
Par che al prisco splendore
Levi la fronte ancora.
Nella novella aurora
Si affissano i gagliardi.
Ascoltatemi, o Sardi,
Io vi schiudo la via.
46. Custa, pobulos, est s’hora
D’estirpare sos abusos!
A terra sos malos usos,
A terra su dispotismu;
Gherra, gherra a s’egoismu,
Et gherra a sos oppressores;
Custos tirannos minores
Est prezisu humiliare.
46. Popoli, è giunta l’ora
D’infrangere gli abusi;
A terra, a terra gli usi
Malvagi e il dispotismo.
Sia guerra all’egoismo,
Sia guerra agli oppressori
I piccioli signori
Devono a noi piegare.
47. Si no, chalchi die a mossu
Bo ‘nde segade’ su didu.
Como ch’est su filu ordidu
A bois toccat a tèssere,
Mizzi chi poi det essere
Tardu s ‘arrepentimentu;
Cando si tenet su bentu
Est prezisu bentulare.
47. Non osi chi fu inerte
Mordersi un dì le dita;
Or che la tela è ordita
Date una mano a tessere.
Tardo vi potrebbe essere
Un giorno il pentimento;
Quando si leva il vento
E’ d’uopo trebbiare.
Article printed from Fondazione Sardinia: http://www.fondazionesardinia.eu/ita
URL to article: http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?p=17408
Click here to print.